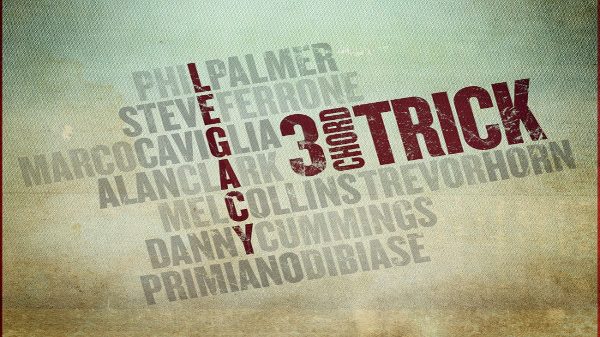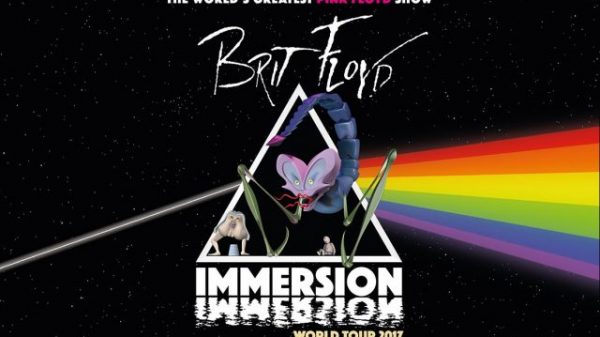Ci sono musicisti per i quali saper suonare bene uno strumento risulta essere un’ovvietà, saper emozionare migliaia di persone con qualche vibrazione pure e, già che ci siamo, anche l’aver accomunato nell’ascolto due o tre generazioni differenti.
Parliamo degli stessi che hanno scritto quelle canzoni che sentiamo ancora nelle radio – anch’esse ormai dati di fatto, come se si fossero composte da sole –, quelli che hanno riempito stadi in tutto il mondo, così come pagine indelebili della storia della musica recente e futura. Per gente come loro essere delle leggende viventi sembra ormai un attributo comune come l’essere: alti, bassi, grassi, magri, capelluti o calvi. Come a dire, si nasce in tante forme: albero o sasso, acqua o farfalla… o Elettra Lamborgini. E che si nasce anche fenomeni della musica. Mark Knopfler deve rientrare per forza in questa categoria, visto che ormai lodarlo per la sua bravura sembra essere scontato come dire che “l’acqua è bagnata” e che questa recensione potrebbe finire qui senza andare oltre, con qualcosa di più simile a una preghiera che altro.
Se non possiamo parlare di quanto Mark Knopfler sia un asso della chitarra – appunto, per non essere scontati – e se non vogliamo far sconfinare nell’agiografia sacra questa recensione, sarà bene soffermarsi su tutti quegli aspetti che, lo scorso 21 luglio presso le terme di Caracalla, hanno reso più umano il suo spettacolo, regalando al pubblico di Roma uno dei concerti più interessanti del ricco palinsesto estivo.
Ma cosa è a rendere umano uno come Knopfler? Beh, anzitutto il fatto di invecchiare direi e, questo non è per niente scontato, il saperlo fare con dignità e cura. Si, perché il Mark che in questi giorni se ne va in giro per l’Europa, non è più l’ineguagliabile virtuoso delle sei corde che saltellava con una bandana in testa e un polsino da tennista (cioè, il polsino c’è ancora, ma non saltella più). È piuttosto un anziano signore, dall’aspetto abbastanza comune, che sale sul palco con fare gioviale, pacifico e un po’ goffo, terrorizzando il pubblico quando dice di volersi ritirare perché troppo vecchio. Inutile dire che a fronte di questa imperdonabile minaccia le migliaia di paganti presenti abbiamo travolto di urla amichevoli e cordiali quel signore lì che, nel frattempo, si è trasformato in un saggio cantastorie intento a raccontare la sua vita senza mai prendersi troppo sul serio.
“Vi ho mai detto di quella volta che cercai di raggiungere casa in autostop durante un freddo dicembre britannico, ed ero rimasto sepolto dalla neve, io e la mia chitarra?”, è il sunto di un lungo e disinvolto discorso votato a introdurre Matchstick Man, una delle perle estrapolate dall’ultimo disco, “Down the Road Wherever”. È una ballata intima e ricca di sentimento, intrisa di ricordi di un giovane incosciente ormai lontano, che alla chitarra acustica e alla voce – protagonisti assoluti della versione studio – vede aggiunti splendidi arrangiamenti di fiati, violini, percussioni e tanta, tanta dinamica.
Atmosfere suggestive, un canto tutto personale, classe, l’umiltà verso più tradizioni musicali da derubare ma riutilizzare con rispetto, queste le cifre distintive dell’ultimo Knopfler, quello che da inizio Duemila ha sfornato dischi perfetti senza mai fermarsi, perle su perle, ingrandendo a dismisura un repertorio smisurato. Il pubblico, quello selezionato e non idolatra, ne viene immediatamente catturato, e gli applausi, i cori e poi gli improvvisi silenzi su My Bacon Roll, altra canzone riuscitissima dall’ultimo album, sembrano andare verso questa direzione.
I Dire Straits sono lontani e a Mark non interessa avere 100.000 persone sotto i piedi a riprendere con i telefoni (dannatissimi telefoni!!!) l’ennesima reiterazione del solo di Sultans of Swing. La scaletta è sempre equilibrata, non celebra mai la leggenda che invece sembra voler sparire in un contesto intimista e ben più modesto, quello di un fumoso club jazz di tempi immemori. E l’intento deve essere perfettamente riuscito se si pensa alla naturalezza, la normalità con cui – dopo le due canzoni d’apertura non esaltanti, causa problemi in cabina di mixaggio – Knopfler and his band regalano alle terme di Caracalla un trittico mostruoso che da solo varrebbe il prezzo del biglietto. Neanche ora c’è spazio per la celebrazione, per il “quanto sono bravo” o per “questo è un classico, preparatevi”, nemmeno quando suoni prima Sailing to Philadelphia, poi Once Upon a Time in the West– e lì se qualcuno ha il cuore sensibile rischia la vita, perché è davvero troppo – e alla fine quel piccolo grande capolavoro che è Romeo and Juliet.
Brani leggendari, tutti e tre, riarrangiati, depurati della patina dorata e restituiti al pubblico nella loro essenza più pura, quella della canzone come fragile essenza in grado di prendere ogni possibile direzione nelle mani di grandi musicisti. E a proposito di grandi musicisti, non si può non parlare della band straordinaria che ha accompagnato Knopfler per quella serata. Proprio nel lungo discorso di presentazione dei dieci (dieci!!) compagni di viaggio, Mark torna l’anziano cantastorie che umilmente ricorda al pubblico “io suono solo uno strumento”, mentre il resto della band è costituita da polistrumentisti eccellenti. Guy Fletcher ha suonato ogni tastiera possibile e immaginabile; Danny Cummings percussionista, corista e showman impareggiabile; Mike McGoldrick ai flauti, in ogni possibile accezione; Graeme Blevins al sassofono; John McCusker mostruoso al violino e addirittura alla cetra rinascimentale; Ian Thomas alle pelli; Gleen Wolf storico bassista ed eccellente contrabbassista; Tom Walsh alla tromba; Jon Cox al piano e alla fisarmonica; e Richard Bennet che ha suonato chitarre di ogni tipo e ha prestato la sua voce in più occasioni.

Il palco era affollatissimo anche a causa della necessità di cambiare strumenti – spesso nel mezzo della canzone – e in alcuni momenti, tra musicisti e tecnici, si sfioravano le venti persone sulla scena. “Sembra la nazionale di calcio” qualcuno ha commentato con ironia, e in effetti poco ci mancava. Mark ha sfoggiato tutto il suo classico repertorio di chitarre: acustiche, resofoniche, elettriche, con nota di merito per il suono della Stratocaster rossa che, con quell’attacco netto, pizzicato con pollice e indice, riuscirebbe a bucare anche il cuore e l’orecchio più duro.
Quello che ha stupito di più tuttavia – anche questo non così scontato al giorno d’oggi, soprattutto alla luce del numero di comprimari – è l’equilibrio costante dei pezzi, che nonostante il mix affollato di strumenti è apparso sempre ben bilanciato, tanto da rendere difficile capire chi suonasse cosa, come fosse un’orchestra. La musica fuoriusciva dalle casse in modo omogeneo, come un’unica entità, con la sola chitarra di Mark a fare la differenza, grazie alla sua voce caratteristica.
Le canzoni vanno via con leggerezza, regalando all’ascoltatore atmosfere, mondi e tempi sconfinati, forse a tratti irreali. È stata la dinamica la chiave vincente del tutto, tanto all’interno della scaletta – in grado di passare dall’intimo e suggestiva jazzato di Heart Full of Holes all’esotica cavalcata sudamericana di Postcards from Paraguay dominata dai fiati – che all’interno delle stesse canzoni. Su tutte, la performance di Done With Bonaparte ha regalato una commistione perfetta di intrecci di strumenti, alti e bassi, forti e piano, luci e ombre in grado di rendere il pezzo uno dei più interessanti. Dall’incontro di dobro e bouzouki si passa al violino, poi la fisarmonica, percussioni varie e la bellissima uillean pipe irlandese.
E proprio quest’unione di strumenti più sdoganati con quelli meno convenzionali, o meglio, meno utilizzati nella musica pop, ha reso ogni pezzo non solo bello da ascoltare ma anche affascinante nella sua singolarità, tanto da far passare – paradossalmente – una Money for Nothing come il momento più scontato della serata, nonostante l’inevitabile successo del pezzo sui fan. Questo non vuol dire che i classici del Knopfler virtuoso siano finiti in secondo piano, anzi. Giocando a nascondino tra pezzi riarrangiati, fraseggi poetici e minimali, la chitarra di Mark – quando ha voluto – ha saputo emergere lentamente, fino a diventare maestosa, ma senza strafare, nei crescendo di Speedway at Nazareth – un climax di bellezza, emozione e decisi echi di rock n’roll che non muoiono mai – o la bellissima Going Home: Theme From Local Hero con cui il concerto si conclude lasciando spazio a una standing ovation di minuti e minuti.

Allontanandosi dai fasti del guitar hero leggendario, umanizzandosi, e invecchiando a dovere, Mark saluta un pubblico che resta attonito di fronte alla bellezza e alla rarità di un’esibizione del genere. A colpire stavolta non sono stati i riff memorabili, né la commozione di fronte al ritornello noto – cantato e ricantato – e nemmeno la consapevolezza di essere in presenza della leggenda, che ha saputo ben nascondersi dall’essere tale.
L’esibizione, nel suo complesso, si è posta prima di tutto, anteponendosi al personaggio, alle hit storiche, al passato glorioso. Restano vivi i paesaggi e le immagini fissate nelle orecchie e nella mente: la bellezza del suono, i riarrangiamenti suggestivi, i tratti esotico/onirico/intimisti di musica viva e non ammuffita e cristallizzata nella mente. O anche il riflesso delle luci sul Dobro National che sembra una carezza gentile da parte di quel signore lì che lascia sorridendo il palco, un po’ incurvato, forse piegato dal peso della grande musica che ha saputo regalare.
Scaletta
“Why Aye Man”
“Corned Beef City”
“Sailing to Philadelphia”
“Once Upon a Time in the West”
“Romeo and Juliet”
“My Bacon Roll”
“Matchstick Man”
“Done With Bonaparte”
“Heart Full of Holes”
“She’s Gone”
“Your Latest Trick”
“Postcards From Paraguay”
“On Every Street”
“Speedway at Nazareth”
Bis:
“Money for Nothing”
“Going Home: Theme from Local Hero”
p.s. Per gli organizzatori dell’evento: la prossima volta le poltrone montatele come si deve, altrimenti dovrete risarcire il collo di buona parte degli spettatori, il concerto lo si vuole vedere senza sbattere la testa sui capelli di chi si ha seduto davanti.
p.p.s. Per il pubblico, io vi direi di spegnerli, ma se proprio dovete, la luminosità ai telefonini potreste abbassarla invece di accecare chi vi sta accanto.
Matteo Palombi – Onda Musicale