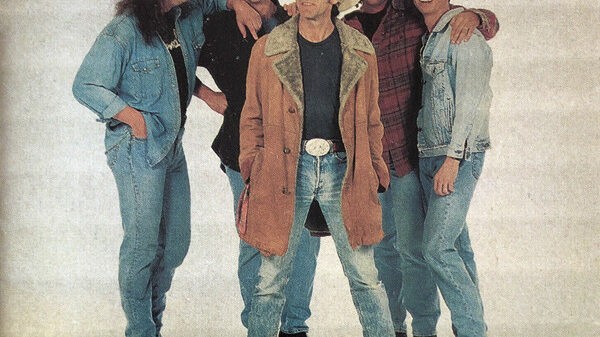Erano bastati due anni di lontananza, sufficienti a far perdere le tracce di sé e della sua chitarra con cui straziava anche i più pazienti dei suoi ascoltatori, e non solo gli altri musicisti.
Ma cosa avesse fatto Robert Johnson, il grande bluesman degli anni trenta del secolo scorso, durante quegli anni, oltre a vagabondare nella zona del delta del Mississipi, per suonare dove lo sopportassero, scappare al ricordo della moglie molto amata e morta troppo giovane, e ai mariti o fidanzati delle tante donne che gli si concedevano, rimaneva un mistero. Che presto finì per alimentare il mito aleggiante attorno alla sua improvvisa bravura tecnica. Una autentica meraviglia per chi lo aveva conosciuto prima, prima che vendesse l’anima al diavolo in cambio di quell’immenso talento musicale.
Era stato sufficiente, dicevano, fermarsi ad un quadrivio poco prima della mezzanotte ed aspettare che arrivasse un grosso uomo nero che gli avrebbe preso la chitarra, gliel’avrebbe accordata, avrebbe suonato un pezzo ed infine gliel’avrebbe restituita trasformandolo, forse, nel musicista blues più importante di tutti. Non è il solo musicista a cui il diavolo avrebbe concesso i propri favori in cambio dell’anima. Si diceva anche di Niccolò Paganini il cui virtuosismo al violino era tale da far svenire gli spettatori che lo vedevano esibirsi, e accanto al quale qualcuno asseriva di avere visto il demonio in persona.
Eppure deve esserci un metodo decisamente meno oneroso per apprendere la tecnica musicale. Sicuramente quello che si impara nei conservatori, o presso maestri privati. Certo il percorso ufficiale che prepara sicuramente ottimi musicisti. Perché se è fuori di dubbio che poco c’entri il diavolo nell’apprendere il linguaggio della musica, è altrettanto vero che esistono decine di musicisti, non importa se di successo o meno, che del conservatorio, o di maestri privati hanno fatto decisamente a meno.

E tuttavia credere che il genio (anche nel caso di Robert Johnson), perché di questo andiamo parlando, possa materializzarsi in totale assenza di un metodo, magari del tutto personale, quasi che il talento sia da solo capace di regalare bellezza ed estasi, attraverso la musica, o qualsiasi forma d’arte, sarebbe davvero ingenuo. Certo, del genio si potrebbe dire che è quanto di meno democratico si possa pensare, quanto di meno codificato, normalizzato si possa aver in un essere umano. E per tanto, in un’epoca che non vuole altro che normalizzare, omologare, catalogare sì che possa chiunque rientrare in una categoria commerciale, la presenza del genio e già di se perturbante. Uso questo termine non a caso, ripensando alla penna di un genio, ma della parola scritta. Thomas Bernhard che del genio ha lungamente scritto in uno dei suoi romanzi più riusciti. Solo che lui nel Soccombente, non si mette ad osservare il mondo dalla parte del genio, ma degli amici, compagni di studio che lo guardano, che lo vedono crescere ben oltre le loro pur non indifferenti virtù di “suonatori di pianoforte”.
Proviamo ad immaginare cosa accadrebbe se improvvisamente, o peggio ancora, lentamente quasi fosse una tortura, vi accorgeste che il vostro talento non sarebbe nulla davanti al genio. Perché un conto è parlarne, rimanerne esaltati finché se ne è lontani, ma quando il genio ci siede accanto, e magari è un amico o un compagno di studi, cosa fareste? Potreste cedere e ritirarvi nel silenzio, abbandonare una carriera artistica, il sogno, come appunto i compagni di studio di Glenn Gould. Oppure rimanere estasiati dinanzi al talento come Haydn quando riconobbe il genio del giovanissimo Mozart.
Molto più umana e calorosa è la profonda invidia per la musica di cui era “affetto” Giorgio Manganelli. Che è l’invidia dello scrittore per il musicista o meglio ancora, l’invidia per una condizione più libera. Ha ragione Manganelli, nessuno ha la possibilità di librarsi con la leggerezza del musicista sulle tristezze umane. Che pochi musicisti come Beethoven hanno vissuto sulla propria pelle, direttamente, trovando consolazione alle sventure fisiche solo nella musica, nella propria creazione, visionaria e, come avrebbe detto Kant, quasi senza sapere dove lo stava portando. Come spiegare infatti la sonata per pianoforte numero 32 opera 111 dove all’insaputa e assolutamente in maniera preveggente, nell’arietta, sembra di sentire il vagito di quel ragtime, che solo cento anni più tardi contribuirà alla nascita del jazz.
Eppure, questo tema del genio è assai ricorrente e non è solo della musica. Vengono in mente alcuni film degli ultimi anni che girano attorno a questo mistero, al mistero della creazione artistica, al genio inatteso e per lo più misconosciuto, o peggio, non riconosciuto. Penso al film A proposito di Davis dei fratelli Coen, al pluripremiato Birdman di Inarritu. In fondo la domanda è sempre la stessa, cos’è il talento, il genio, e dove si trova, e soprattutto sappiamo riconoscerlo o ne proviamo, al cospetto, un misto di gioia ed invidia, quando non si tratta di rabbia e gelosia?
Quanti musicisti come Dave Van Ronk, il musicista folk cui si sono ispirati i fratelli Coen, pure nella totale ignoranza delle tecniche scolastiche, nell’incapacità di leggere uno spartito, hanno tentato chi con successo chi miseramente, di tirare fuori magia dalla propria musica malgrado i sacrifici, la lotta con se stessi, il disinteresse dei produttori e spesso anche del pubblico, la voracità del mercato che presto chiede nuovi eroi, nuovi genii. E di contro quel percorso iniziatico che conduce Neiman, il protagonista di Whiplash, con il professor Fletcher, alla padronanza di sé e dello strumento, la batteria, attraverso una lunghissima battaglia psicologica fra i due che vedrà trionfare né l’uno né l’altro, né tantomeno l’idea di successo, ma semmai la musica, severa e indifferente, del sacrificio umano, madre e matrigna che elargisce il dono del divertimento. Perché è questo che il professor Fletcher dice alla sua band prima di salire sul palco, andiamo a divertirci.
Un tratto che per esempio era presente in Mozart, e come lui in tanti altri musicisti, l’assoluta apparente mancanza di fatica, l’apparente facilità di tutto quel che le sue dita sapevano tirare fuori dal pianoforte. Staccarlo da quella tastiera non era cosa facile. Ed è lì che finirà i suoi giorni componendo il Requiem. Nell’arte, nell’artista, gioia e dolore, angoscia e gioco, gioco e morte coesistono continuamente, ricorda Giorgio Manganelli in una delle interviste rilasciate a Paolo Terni su Radio3 nel 1980 (e meritoriamente ripubblicate lo scorso anno appunto con il titolo di Una profonda invidia per la musica edito da L’Orma), sono inseparabili ed auspicabili.
Del resto, persino il Lombroso, parlando del genio, lo descrive come un alienato. Al culmine dello slancio creativo, il genio, non necessariamente artistico, gli sembra pencolante, come Paganini con il suo violino, oppure Van Gogh e le sue tele, tra la pazzia e la ragione. Numerosi gli esempi che si potrebbero portare a dimostrazione di questo equilibrio, tante volte estremamente precario, tra genio e sregolatezza. La storia dell’arte, di qualsiasi arte, ne è piena. Rimanendo in ambito musicale, basterebbe fare il nome di Charlie Parker, di Jimi Hendrix la cui biografia è davvero paradigmatica di quel che si può intendere per genio.
Difficile infatti definire il genio se non in termini diretti, come dire esemplari, e se la distinzione in latino tra genium, acutezza di intelletto, e studium, capacità acquisita attraverso un impegno lungo, sembra essere sufficiente, in realtà si perderebbe la prospettiva più vasta che per esempio il Rinascimento ha definendo il multiforme ingegno, il cui superbo modello è certamente Leonardo, dell’uomo di genio. O l’apertura che fa Kant quando considera l’arte geniale libera di vincoli di metodo o regole.
Ma sfugge ancora qualcosa, forse una domanda, piuttosto che una definizione, a cosa serva o a chi giovi infine il genio, o l’opera di genio. Perché al di là delle esperienze dirette, delle definizioni più o meno precise, c’è qualcosa che forse solo la mente di un altro genio, poteva sentire tanto forte e pervasiva.
Dice Leopardi nello Zibaldone
Le opere di genio, quando anche rappresentino al vivo la nullità delle cose, quando anche dimostrano evidentemente e facciano sentire l’inevitabile infelicità della vita, quando anche esprimano le più terribili disperazioni, tuttavia, ad un animo grande che si trovi anche in uno stato di estremo abbattimento, servono sempre di consolazione.”
Un fiore nel deserto, appunto, il profumo di ginestra che si spande sopra la cenere che ammanta il Vesuvio, e per esteso, il mondo sottostante. L’unico fiore capace di crescere nella desolazione del deserto, il cui profumo, senza pretesa di trasformarsi in preghiera, così come il genio e la sua opera sono legati all’essere umano che l’ha creata, non è che consolazione per l’uomo che al nulla deve inevitabilmente tornare.
(realizzato da Massimo Turtulici)