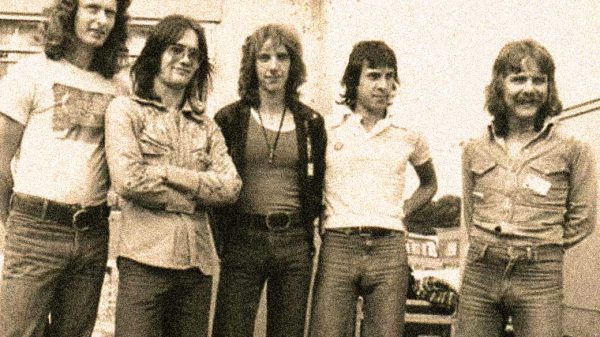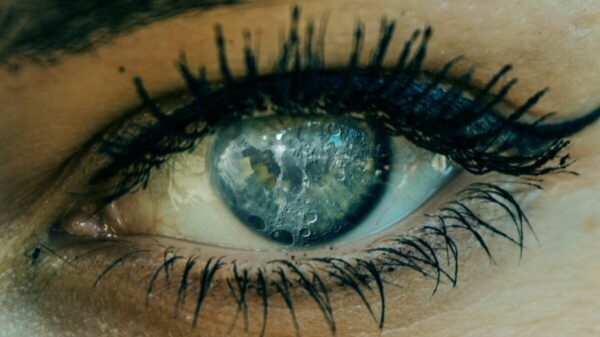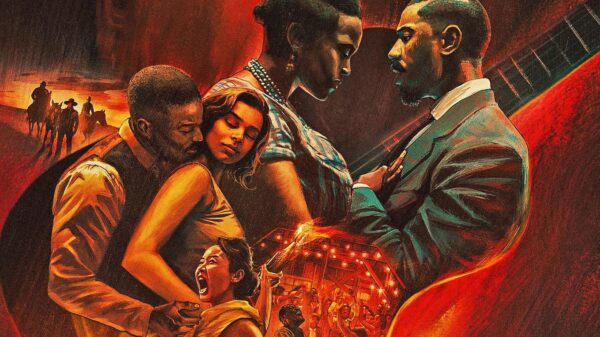Giovedì 13 ottobre ore 20.45 a Trento, presso la Sala Società Filarmonica – ore 20.45 concerto con Vilde Frang, violino e Aleksander Madzar, pianoforte.
Notata giovanissima per la sua espressività e completo dominio tecnico, Vilde Frang è considerata la più interessante violinista della sua generazione. Nel 2012 le è stato assegnato il prestigioso Credit Suisse Young Artists Award e nel mese di settembre è stata invitata per il debutto al Festival di Lucerna con i Wiener Philharmoniker diretti da Bernard Haitink.
Tra le maggiori orchestre internazionali con cui collabora spiccano la Mahler Chamber Orchestra, London Philharmonic, Philharmonia, Gewandhaus Orchester di Lipsia, St. Petersburg Philharmonic, Orchestre de Paris, NHK Symphony Tokyo; tra i direttori Vladimir Ashkenazy, Ivan Fischer, Vladimir Jurowski, Paavo Järvi, Esa-Pekka Salonen e Yuri Temirkanov. Nella stagione 2015-16 ha debuttato con la Berlin Philharmonic e Simon Rattle. Nel campo della musica da camera collabora abitualmente con Gidon Kremer, Yuri Bashmet, Martha Argerich, Leif Ove Andsnes, Nicolas Altstaedt e il Quartetto Ebène, invitata ai Festival di Salisburgo, Verbier, Lucerna, London Proms, Schleswig-Holstein, Lockenhaus e Prague Spring Festival. Nata in Norvegia nel 1986, è stata scelta da Mariss Jansons all’età di 12 anni per il debutto con la Oslo Philharmonic Orchestra.
Ha studiato con Kolja Blacher alla Musikhochschule di Amburgo e Ana Chumachenco alla Kronberg Academy. Ha lavorato con Mitsuko Uchida nell’ambito del premio Borletti-Buitoni nel 2007 e dal 2003 al 2009 è stata studente borsista della Fondazione Anne-Sophie Mutter. Suona uno Jean-Baptiste Vuillaume del 1864.
La vittoria a Leeds nel 1996 ha lanciato in campo internazionale il giovane pianista, nato a Belgrado nel 1968, Aleksandar Madzar. Oggi dopo essere passato al Busoni di Bolzano (secondo premio con il primo non assegnato nel 1989), Madzar è docente al Conservatorio Reale di Bruxelles e alla Hochschule für Musik und Theater di Berna. Continua però a essere richiesto da orchestre e gruppi cameristici in tutto il mondo, dall'Europa all'America.
“Egli fece risuonare la poesia e parlare la musica. Non padrona e non serva, come sorelle si abbracciano sulla tomba di Schubert”: così recita l’epitaffio, poi scartato, di Franz Grillparzer per la tomba del ‘Liederfürst’ Franz Schubert. Il Lied schubertiano, di cui si contano circa seicento esempi, nobilitò quello che fino a poco prima era considerato un genere minore, conquistando un posto di rilievo nella storia della musica tedesca. La sua produzione strumentale fu invece ben più discontinua, ma trovò nella fase matura un suo equilibrio nella fusione con le categorie della ‘canzone d’arte’. È l’esempio del Lied Sei mir gegrüsst su testo di F. Rückert da cui si sprigiona la Fantasia op. 159 (1827), opera che ebbe una assai tiepida accoglienza dal pubblico e dalla critica viennese.
L’importante eredità di Schubert fu raccolta da Schumann e in seguito da Brahms, che similmente concilia il suo mondo liederistico alla musica assoluta: la sua prima Sonata per violino e pianoforte op. 78 (1879) prende ispirazione da due romanze dell’op. 59 – Nachklang e Regenlied – su testi del poeta K. Groth, tanto da assumere già all’epoca l’appellativo di ‘Regensonate’. Un lavoro nostalgico e meditativo, immerso in una dimensione intima e personale che secondo il critico e amico Hanslick rendeva l’opera poco adatta alla sala da concerto.
Diversi i presupposti delle altre due opere in programma, che si muovono sulle orme ‘folcoriche’: i brani di Isaac Albéniz sono da considerarsi come ritratti del paesaggio musicale spagnolo e andaluso, ricchi di richiami al flamenco e al fandango. La Sonata per violino e pianoforte n. 1 op. 21 di Bartók (1921), dedicata alla giovane Jelly d’Arányi (nipote del violinista Joseph Joachim), si costruisce invece su una forma tripartita di impronta classica, concludendosi sul ritmo energico della danza finale dal sapore tzigano, in una felice unione tra fonti autoctone e linguaggio personale.
Programma della serata:
J. Brahms
(1833-1897)
Sonata n. 1 in Sol magg. op. 78
Vivace ma non troppo – Adagio – Allegro molto moderato
F. Schubert
(1797-1828)
Fantasia in Do magg. per violino e pianoforte op. 159, D. 934
Andante molto – Allegretto. Andantino – Allegro vivace. Allegretto – Presto
________
I. Albeniz
(1860-1909)
Pezzi per violino e pianoforte
B. Bartok
(1881-1945)
Sonata per violino e pianoforte n. 1, op. 21
Allegro appassionato – Adagio – Allegro molto