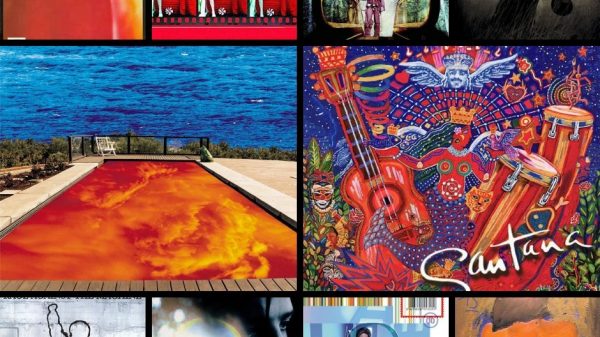Primo settembre 1983 Tom Waits, abbandonata malamente la Elektra/Asylum, manda alle stampe il suo primo album per la Island Records Swordfishtrombones, il primo autoprodotto da Waits, forse l’album più rivoluzionario tra i suoi.
Arriva dopo gli album che hanno fatto di Tom Waits un artista acclamato eppure sin troppo normalizzato nei panni di una sorta di poeta, di crooner influenzato dal jazz, almeno per quello che sentiva di poter fare e raggiungere con la sua musica. Respinto dalla Hollywood più patinata, il nostro intraprende il suo personalissimo viaggio negli inferi di quella America piccola e quotidiana che respira fumo e trasuda birra. Solo l’inizio di un percorso che non si è ancora esaurito e che vedrà di lì a breve la pubblicazione dell’album Rain dogs del 1985 a cui seguirà, a completamento della trilogia, Frank wild years nel 1987.
Ma niente sarebbe stato possibile se non ci fosse stato Swordfishtrombones, se Waits non fosse mutato da crisalide a farfalla, con coraggio affrontando il rischio di perdere almeno una parte dei suoi fan, cosa che accadde ovviamente, per essere però finalmente più libero, di divenire il sublime geniale cantore dei diseredati, dei perdenti, di tutti gli hobo romantici o meno che siano sparsi nel vasto territorio sotterraneo e non solo d’America.
La rivoluzione, alla quale parteciperà in maniera fondamentale Kathleen Brennan, sua moglie, che lo aveva introdotto al rock sperimentale di Captain Beefheart, prima ancora che nei testi, è nelle musiche. Nella strumentazione adoperata, negli arrangiamenti che abbandonano gli archi dei precedenti lavori, e aggiunge al piano e all’organo Hammond una strumentazione orchestrale delle più insolite, oltre al necessario stuolo di musicisti eccellenti, comprendente marimba, tamburi, cornamuse, una grancassa con riso, tromboni e trombe in sordina. Un amalgama che esalta la sua eccentrica genialità, un certo gusto per il cabaret, testimoniato anche dalla foto di copertina che ritrae Tom Waits accanto agli attori Angelo Rossitto e Lee Kolima.
I tredici mesi che passarono dalla registrazione avvenuta nell’agosto del 1982 alla effettiva pubblicazione del settembre 1983, testimoniano delle difficoltà riscontrate nel far accettare un tale radicale cambio di sonorità e non solo alla già citata Elektra/Asylum. Anche se l’album raggiunse solo la posizione centosessantaquattro nella classifica di Billboard, fu classificato al numero due nella lista degli “Album of the Year” di New Musical Express per il 1983.
Reinventatosi o meglio ancora rigeneratosi, liberatosi dei lacci che lo tenevano legato ad una tradizione sin troppo patinata, Waits avvierà un periodo estremamente creativo e dagli esiti entusiasmanti. Musicalmente ci si trova come dinanzi ad un imprevedibile infrangersi di un bicchiere che conteneva non solo bourbon ma anche il talento e la bravura di Waits mostrate ampiamente nei lavori precedenti, in una miriade di pezzi di vetro scintillanti come diamanti. Ogni singolo brano disvela panorami sonori inattesi, melodie sghembe, dissonanti, stridono di suoni che non sempre escono da veri strumenti musicali, quasi che il tuffo in quell’Undergound, segnato non a caso dall’omonimo brano d’apertura, sia proprio un viaggio controcorrente, ironico, doloroso, sfolgorante nel torbido di una America disillusa che la sua musica deve mostrare e non più celare nell’eleganza delle sonorità più morbide e confortevoli.
I quindici brani, le quindici vignette verrebbe da dire, che compongono l’album descrivono in dettaglio quel mondo reale del quale Waits è superbo cantastorie. Le canzoni, i brani strumentali e i monologhi dipingono un mondo sotterraneo fatto di disadattati e squilibrati, molto più oscuro e avvincente dei jazz cafè del suo lavoro precedente. Il tutto intessuto dalla voce di Waits che mai come in questo album passa da ringhi abrasivi ad un approccio più morbido.
La sua voce bassa e potente si concede nei monologhi che non sanno più di bar fumosi, ma di bettole, di taverne buie e malsane
Nessuno meglio di Waits, della sua voce, avrebbe potuto incedere lieve tra le storie che sembrano tratteggiare le musiche che pure sarebbe troppo severo dipingere solo come cupe. La sua voce grezza, a tratti volutamente rozza, raggiunge vette di impareggiabile tenerezza. Ne è esempio la traccia forse più cupa, più triste dell’album che è Soldier’s things nella quale una madre svende le cose appartenute al figlio soldato caduto in battaglia. Oppure nell’omaggio fatto alla cittadina natale di sua moglie nella dolcissima ballata Johnsburg, Illinois.
Poliedrico come non mai, l’album snocciola, apparentemente senza logica, brani cupi a brani incalzanti come Down, down down che mostra il virtuosismo ritmico di Waits in tutta la sua lucentezza. Oppure 16 shells from a 30.6, brano travolgente grazie ai riff di chitarra e al geniale lavoro di batteria e percussioni. Come suo solito, non possono mancare brani in cui l’umorismo sgangherato la fa da padrone, come nel delirante monologo presente in Frank’s wild years un cosiddetto brano talking-jazzy tracciato dal basso attorno al quale l’organo Hammond veleggia libero e indisturbato. In Swordfishtrombones sfodera ancora una volta il suo talento da commediante per tratteggiare una storia di impossibile riscatto sociale.
E che dire di Shore leave, dove le sonorità più discordanti si fondono come se fossero nate proprio per questo
Oppure dei gioielli che sono i brani strumentali quali Rainbird, Just another sucker on the wine o Dave the butcher straniante grazie all’insolito intrecciarsi delle percussioni e dell’organo Hammond. Ancora, Town With no Cheer presenta un assolo di cornamusa irlandese e ha davvero un’atmosfera da Giorno di San Patrizio. Alla fine Tom Waits entra cantando con una voce alquanto profonda su altre cornamuse. In the Neighborhood suona come qualcosa che si potrebbe suonare a un matrimonio, a patto di voler togliere la voce graffiante di Tom Waits. Le trombe suonano in sottofondo e frequenti rulli di tamburi entrano ed escono dalla musica.
Ospiti d’eccezione
Un album che ospita musicisti del calibro di Victor Feldman pianista di Miles Davis in “Seven steps to heaven” del 1963 che qui si cimenta attorno ad una quantità di percussioni a dir poco insolite, o di Greg Cohen al basso, di Fred Tacket chitarrista e membro dei Little feat, di Dick Hyde al trombone già al servizio di Count Basie, Herbie Hancock, Frank Sinatra, Jaco Pastorius, per citare qualcuno. Ci piace comunque sottolineare quanto in effetti sempre ricordato da Tom Waits stesso a proposito della moglie Kathleen Brennan, con la quale ha composto almeno una sessantina di brani, e che ha definito come una presenza incandescente su tutte le canzoni su cui hanno lavorato insieme.
Sono un uomo fortunato. Ha un’immaginazione straordinaria. E questa è la nazione in cui vivo. È audace, inventiva e senza paura”.
Insomma, questa alchemica combinazione di stranezze musicali, testi sinceri e inquietanti crea un album che sfugge al tempo, ne piega il corso e ancora oggi a distanza di trentotto anni ci offre una ghiotta possibilità, quella di andare a riscoprire dove sono le radici del Tom Waits migliore o semplicemente a godere della luminosità delle sue canzoni assolutamente personali e irripetibili.
(articolo realizzato da Massimo Turtulici)