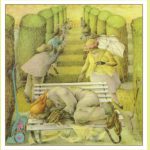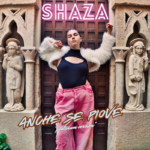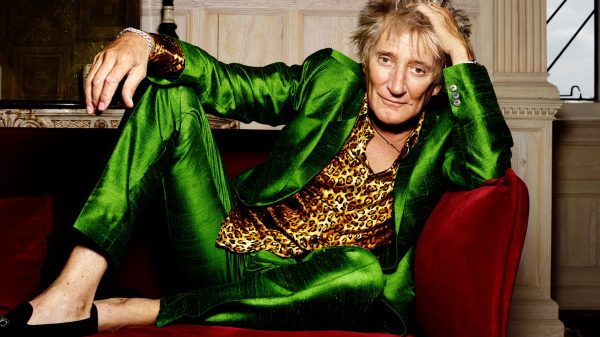Nel 1975, il più classico dei fulmini a ciel sereno – è il 16 agosto – si abbatte sul mondo del prog rock. Via stampa, Peter Gabriel assesta un bel colpo ai compagni di viaggio artistico e al mondo del progressive rock intero annunciando l’abbandono dei Genesis.
Peter Gabriel lo fa con una lettera pubblicata dal Melody Maker che mette in prima pagina una foto del cantante in uno dei suoi più famosi travestimenti, quello con le ali da pipistrello dell’alieno di Watcher Of The Skies.
L’addio ai Genesis
Gabriel ha confessato la sua decisione alla band a Cleveland il 24 novembre 1974, durante una delle prime date del tour di The Lamb Lies Down On Broadway. Poi ha dato loro il tempo di turare la falla. Non solo all’“arcangelo” i Genesis stanno stretti, ma si sono aperte delle fratture insanabili a livello umano (Banks e Rutherford, amici dai tempi di scuola, durante la registrazione di The Lamb… non perdonano a Gabriel le “distrazioni”: la scappatella col regista americano William Friedkin per una sceneggiatura a quattro mani mai compiuta; e anche peggio, il tempo dedicato alla primogenita appena nata ma in pessimo stato di salute). La gente comincia a fare la facile equazione Gabriel = Genesis e questo non piace né al frontman né agli altri quattro. Peter però non ambisce a maggior fama. Cerca nuovi stimoli, anche al di fuori della musica che l’ha snervato.
Il suo intento, come svela nelle lettera aperta, è dedicare più tempo alla famiglia, fare il padre, lavorare su sé stesso, perfino coltivare verdure e godere della vita sociale del vicinato. Insomma prendere tempo. Il ragazzo – perché ancora tale è – ha avuto il coraggio di lasciare i Genesis all’apice della creatività e della fama (fino allora) ma è conscio di essere uscito dal nido privo della certezza di sapere volare. Impiega due anni per riuscire a farlo. Prima affinandosi, poi affidandosi alle mani di un produttore che sappia tirare fuori da lui l’inaspettabile (lo slogan che caratterizza la campagna di marketing per vendere il disco è “expect the unexpected”).
Bob Ezrin sin qui ha realizzato le aspettative di Alice Cooper e Lou Reed
Lavora in fretta e bene, e sembra disposto ad ascoltare le esigenze di Gabriel, che cerca empatia. Oltre che qualcuno al quale vuole cedere la responsabilità del versante più arrembante della musica che ha in mente. Lui vuole gestire i momenti più intimi, come ha fatto nella band che lo ha reso uno dei personaggi più stimati della musica degli anni ‘70. Ezrin mette insieme una squadra di cowboy veloci di testa (nel capire) e di mano, che dovranno logorare ma non cancellare le certezze culturali dell’ex voce dei Genesis. E a precisa richiesta – almeno un inglese in mezzo allo strapotere yankee – il cantante ottiene la presenza di Robert Fripp, col quale ha stretto un bel rapporto da quando l’occhialuto chitarrista ha disintegrato i King Crimson ed è diventato un discepolo degli insegnamenti del controverso mistico e filosofo di origini armene Georges Ivanovič Gurdjieff.

Peter Gabriel I (o “Car”, com’è stato in seguito ribattezzato)
È davvero “inaspettata” la musica che esce dai solchi di Peter Gabriel I (o Car, com’è stato in seguito ribattezzato)? Il nuovo Gabriel è in realtà compreso tra l’incipit di Moribund the Burgermeister, che pare tessere un filo diretto con The Colony of the Slippermen, una delle prove più fantasiose del suo ultimo lavoro coi Genesis – uno sfondo e personaggi tra scienza e superstizione (il Ballo di S. Vito, il pifferaio), voci distorte, suoni tra fantasy/horror & oltremondo – e Humdrum: dal piano elettrico soffuso, nacchere e un fuorviante deragliare a ritmo di tango che apre al maestoso finale e deve avere fatto l’invidia di Tony Banks (qualcuno potrebbe averlo trattenuto, pronto col mellotron a soverchiare l’orchestra intera approntata da Ezrin, per fare vedere come si fa).
Sul lato B ci sono Slowburn, che al di là degli strappi orchestrali finisce su un binario che ricorda ancora i Genesis (la delicata coda di Dancing with the Monlit Knight, e pure di A Trick of the Tail, la canzone dell’omonimo disco dei Genesis pubblicato nel 1976), e il caleidoscopico e imponente disegno di Down the Dolce Vita che frulla di tutto, a ricordare un passato che non si può cancellare, non in due anni almeno: rock’n’roll, disco, classica, e appunto prog rock d’antan. Un kolossal che non per nulla sfocia senza soluzione di continuità in uno dei due brani che hanno fatto la fortuna del disco e – in buona parte – di Gabriel stesso. Al punto da non averli mai accantonati sul palco, totem al centro della sua agorà live. Uno dei quali è la pietra dello scandalo: su istigazione di Fripp, il primo a lamentarsene, Gabriel rinfaccerà a Bob Ezrin, a giochi fatti, di esserci andato pesante col make-up; al punto che da allora in avanti eseguirà il brano facendone un esercizio di sottrazione, solo voce e tastiere, in regime autarchico.
La bellissima e struggente Solsbury Hill
L’altro passepartout musicale che tutti vogliono ascoltare è Solsbury Hill, il primo singolo della carriera solista di Gabriel che assestandosi al 13° posto in UK e al 68° negli USA è un successo immediato e fa schizzare l’album in classifica. Narra della incertezza di lasciare la vecchia via per intraprendere un nuovo cammino, con chiaro riferimento ai Genesis:
My friends would think I was a nut (I mie amici pensavano fossi matto) / Open doors would soon be shut (Che le porte aperte si sarebbero presto chiuse) / I walked right out of the machinery (Ma sono uscito dall’ingranaggio) / I will show another me (E mostrerò un altro me).”
Ma l’aura di serenità, quasi di trattenuto ottimismo che l’avvolge ne ha fatto una canzone che ricorre in film, serie TV e perfino spot pubblicitari, continuando a perpetuarne la popolarità fino a farlo diventare, oramai si può dire, un classico.
Il Gabriel che non ti aspetti
Il Gabriel unexpected, semmai, scaturisce dalle ruvidezze di Modern Love, tra riff di chitarra urticanti e il cantante che si sgola nelle vesti che non gli cadono del tutto a pennello di all-american rocker; da Excuse Me che tra vaudeville e parodia è però parte del background del Gabriel che conoscevamo, poiché scritta insieme a Martin Hall, cabarettista inglese che il musicista di Bath aveva intenzione di produrre quando ancora indeciso su cosa fare. E soprattutto da Waiting for the Big One, un blues con risvolti da gospel, torcibudella, strascicato, estremamente credibile e centrato, e una prova di gruppo strepitosa. E non solo di facciata – la performance –, perché le parole raccolgono i dubbi sollevati da Solsbury Hill:
«Looking for the real thing (Cerco qualcosa di reale) / It don’t come from what I do (Che non proviene da ciò che faccio) / I’m beginning to think I’m just out of place (Inizio a pensare che non sono nel posto giusto)».
Come a cantarle ancora ai vecchi amici. Per vuotare il sacco una volta per tutte e ricominciare con la testa libera.

Col passare degli anni Gabriel si è ravveduto
Deve avere capito che I non è quel disastro che Robert Fripp andava lamentando imputando le colpe al produttore. Nel 2010 ha chiamato Bob Ezrin per affiancarlo nelle produzione di Scratch My Back. Per essere onesti e dare a Cesare ciò che gli spetta, basterebbe ricordare come ciò che caratterizza Solsbury Hill è frutto dei suggerimenti del canadese: sua è l’idea di mettere nelle mani di Steve Hunter la 12 corde acustica, triplicata in fase di registrazione, dopo un iniziale approccio elettrico. Così come Larry Fast aggiunse ritocchi e tastiere una volta rimasto solo in studio. Nonostante Gabriel non sia mai risultato a tratti così heavy, né prime né dopo, si trattò di un lavoro di gruppo. Di un ottimo lavoro di gruppo.
Un brano intimista per soli voce, piano e chitarra
Per quanto concerne Here Comes the Flood l’idea di Gabriel era di farne un brano intimista per soli voce, piano e chitarra, come poi realizzò nella versione comparsa su Exposure di Fripp uscito due anni dopo. Ezrin addobba invece per stupire, come si addice a un finale che deve lasciare attorno all’ascoltatore un’eco che toglie spazio all’aria. Fatto di pieni orchestrali ma anche di minuscoli dettagli. Qualcosa di epico e determinante come As Sure as Eggs Is Eggs (Aching Men’s Feet), il finale di Supper’s Ready: se Gabriel fosse rimasto in famiglia e avesse portato alle prove il demo, Here Comes The Flood ne sarebbe uscita molto simile a com’è su PG I.

L’illuminazione arriva una notte
Signore, ecco il diluvio. Gabriel dice di avere avuto l’illuminazione ascoltando la radio di notte, e di riferirsi a una inondazione dei pensieri nelle menti sulla scorta dei segnali che captava attraverso l’apparecchio. Anche da un sogno nel quale la gente aveva il potere di introdursi nella testa degli altri. Ma Dio vien citato, il Diluvio altrettanto: simboli universali che ricorrono in tutte le religioni e in tutte le tradizioni, e i simboli si possono interpretare. In questo senso si può dire che Peter Gabriel ha scritto il libretto, e Bob Ezrin da regista ha allestito una messa in scena dantesca: in angolo c’è l’umanità sgomenta in attesa di responso, mentre il Signore e le torme degli angeli schierate lassù in alto sono pronti a rovesciare la punizione che laverà il mondo.
Gabriel nella sua interpretazione favorita – dove poliedrico fa il regista, l’attore, il musicista – è da solo, il Signore (o chi per lui, decida l’ascoltatore, le parole sono ambigue) unico interlocutore. Cambia la scala; non la tensione, non l’intensità. Here Comes the Flood, così com’è, sigilla in modo magistrale un esordio che migliore, difetti compresi, non poteva essere. Gabriel cambia squadra e modulo. Continuerà a farlo fino a trovare lo schema per suonare/giocare (to play) a lui più adatto. Impiegherà ancora un po’ di tempo, ma la strada è quella giusta.
(articolo scritto da Andrea C. Soncini per sentireascoltare.com)