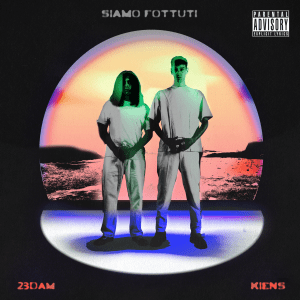Un passo decisamente a ritroso quello che viviamo con “Pianeti” il nuovo disco del duo veneto dei Bob Balera.
Un disco che a Lucio Battisti dell’era Mogol deve molto, per le intenzioni così come per quel certo modo di pensare alla melodia, liquida, sottile, ficcante sin dal primo ascolto. Ma poi la ricerca spazia anche dentro quel connubio acustico e digitale che significa anche una decorosa consapevolezza d’attualità. L’amore è al centro, certamente… ma i “Pianeti” dei Bob Balera siamo tutti noi e non solo nei rapporti di cuore. Il romanticismo del disco, in questa chiave, diviene una scusa per navigare a vista dentro le pieghe del sociale.
Dentro le pieghe della canzone italiana di qualche elencazione fa. In primis parliamo di quel passato: come e perché si manifesta così prepotentemente nelle vostre scritture?
«Credo perché parte imprescindibile dei nostri ascolti fin dalla più tenera età, quindi sedimentato in profondità nel nostro DNA. Queste sonorità ci trasportano al periodo della nostra adolescenza, con tutto il bagaglio di romanticismo proprio della malinconia del ricordo».
E poi parliamo anche del futuro perché il disco sa bene come fare anche in tal senso. Dal futuro che prendete?
«Dal futuro prendiamo la speranza che sia possibile fare del pop in italiano come succedeva ormai tempo fa, quando il fare canzoni era un lavoro artigianale, meno omologato alle dinamiche dell’odierna musica “industriale”, prodotto secondario atto a veicolare piuttosto l’immagine, l’estetica, che il contenuto. Una sorta di “decrescita felice” in ambito musicale».
E su tutto, esiste anche un retrogusto prog nel pop dei Bob Balera secondo voi? Tanto per restare in tema “Battisti”…
«Ci piace mescolare le carte, pur cercando di mantenere la barra a dritta scrivendo canzoni melodiche e potenzialmente fruibili da un pubblico felicemente generalista. C’è qualche velato accenno di prog, come scrivi, che ci è stato piacevolmente fatto notare in diverse occasioni… veniamo da una terra (il veneto) che ha scritto pagine importanti in passato come ora in ambito progressive, e in qualche modo è qualcosa che abbiamo metabolizzato».
E dal suono… che cosa volevate raggiungere? E alla fine dei conti, cosa sentite di aver raggiunto?
«È stato un disco dalla gestazione veramente lunga e dolorosa, in primis per la morte improvvisa del nostro primo produttore, Claudio Corradini, avvenuta in circostanze ancora poco chiare, proprio mentre stavamo terminando la fase di missaggio. Lavorando con Sandro Franchin abbiamo approfondito la vena più rock e chitarristica, curando maniacalmente i suoni delle tastiere di Marco Boem, per mettere un piede nelle sonorità attuali. Onestamente, non cambierei una virgola dell’album, abbiamo raggiunto la piena soddisfazione, che è molto».
“Pianeti” è anche una bella allegoria pensando ai tanti rapporti umani. Dunque questo è un disco che cerca soluzioni o un disco che le trova?
«Non abbiamo nessuna risposta o soluzione, siamo piuttosto lacerati dai dubbi, quello che cerchiamo di fare e metterli in musica suggerendo una chiave di lettura di “guascona resilienza”».