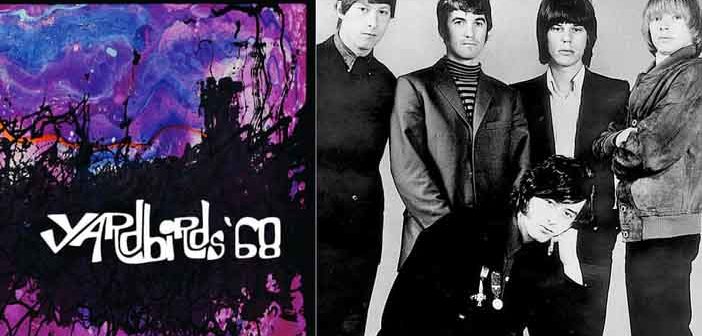La seconda parte della nostra monografia sui Deep Purple prende le mosse all’indomani di In Rock, l’album che inaugura il loro periodo d’oro nel 1970.
Oggi, col beneficio della posterità, la progressione dei Deep Purple sembra quanto di più naturale si possa immaginare. All’epoca la situazione non è così semplice. L’hard rock è appena nato, l’heavy metal è di là da venire e gli appassionati del suono più duro non hanno ancora le idee ben chiare. Non solo, l’hard rock, che oggi siamo abituati a considerare una nicchia di mercato, all’epoca è invece il genere su cui sono puntati tutti gli occhi.
I fan sono così divisi tra il blues accelerato, pesante e dilatato dei primi Led Zeppelin, l’hard spruzzato di ingenuo esoterismo dei Black Sabbath, una miriade di complessi che tentano di adattare ai tempi l’hard blues di Cream e Jimi Hendrix e complessi come i Deep Purple e gli Uriah Heep che tentano di seguire strade lontane dal blues.
In questo contesto, con la casa discografica che impone un vero tour de force per avere subito il seguito di In Rock, i Deep Purple temono di restare ingabbiati nel suono duro e puro del disco che li ha consacrati. Nasce così Fireball, disco bello e vario che però non ripete – se non in parte – il successo del predecessore.
Fireball è un lavoro che si permette di sperimentare un po’ di più, cercando di allargare lo spettro sonoro. C’è qualche accenno psichedelico, mescolato con quelli che sono i solchi più rock blues registrati fino ad allora dalla band (Demon’s Eye), mentre l’hard rock archetipico della band si fa sentire solo in alcuni brani (Fireball e No One Came), fino al paradosso di un passaggio al limite del country, Anyone’s Daughter.
La consacrazione definitiva, però, è dietro l’angolo e si chiama Machine Head, album che esce a marzo del 1972. Machine Head è la quadratura del cerchio, un miracolo di equilibrio tra la durezza di In Rock e le istanze più sperimentali della band, un compendio della loro arte che fa somigliare la tracklist quasi a un best of e ne decreta definitivamente l’entrata nell’Olimpo del rock.
In scaletta troviamo la celeberrima e un tantino abusata Smoke on the Water, nata dal famoso incendio di Montreux durante un concerto di Frank Zappa, per dire. Ma anche classici hard come Highway Star, Space Truckin’ e Lazy, il blues di Maybe I’m a Leo. Un discorso a parte meritano la bellissima Never Before, coi suoi cambi di atmosfere, e la sottovalutata Pictures of Home.
Molti ritengono Machine Head l’esito più elevato dei Deep Purple in studio, il disco che segna l’apice e di cui – in seguito – sarà impossibile fare meglio, come Led Zeppelin IV per la loro band rivale.
I ritmi tra tour e registrazioni, tra la vita frenetica della rockstar, che all’epoca è poco meno che Dio in Terra, e gli impegni promozionali, portano la formazione sull’orlo del collasso. I contrasti tra la band e i produttori, ma soprattutto quelli interni tra Gillan e Blackmore, si fanno insostenibili. In questo clima c’è però ancora spazio per quello che diventerà il loro disco più iconico: Made in Japan.
Quando il lavoro esce sul mercato, l’otto dicembre del 1972, i Deep Purple sono una vera macchina da guerra al massimo della potenza di fuoco. Il disco diverrà la pietra di paragone per tutti i futuri live del rock, e tuttora gran parte della critica lo ritiene il miglior disco dal vivo della storia.
All’epoca l’uscita di un disco live non era ancora una tappa obbligata nel percorso delle band. I mezzi per registrare non erano ancora raffinatissimi, in più molti dischi erano pesantemente. Made in Japan si presenta al contrario senza alcuna lavorazione in studio, con i cinque musicisti della formazione Mark II al massimo del loro splendore, ma anche con tutte le imprecisioni che un’esecuzione live comportava, cosa che dà al lavoro quel fascino in più.
Made in Japan è un album doppio, a causa della ricchezza del repertorio e della lunghezza delle versioni dei brani, potenti e dilatate oltremisura. Raramente ci si trova di fronte a musica così ben suonata senza trucchi. Made in Japan è un disco che impressiona per l’onestà ed è una fotografia storica che cattura un momento irripetibile.
A quel punto, però, la vita dei Deep Purple, pur tra gli agi del successo, diventa insostenibile. La band è in tour ininterrottamente da anni. I ragazzi girano il mondo in modo così frenetico senza riuscire a vedere altro che il palco e la stanza d’albergo delle città che visitano. L’ego dei componenti diventa più ingombrante dei camion che trasportano i loro potentissimi impianti da una città all’altra.
In particolare, quello di Ritchie Blackmore, il bizzoso chitarrista poco incline ai compromessi, e quello di Ian Gillan, carismatico frontman. I loro dissapori si fanno man mano più violenti e livorosi, fomentati dalle differenze di carattere e direzione musicale, nonché dalla forzata convivenza.
La band, inoltre, è diventata una macchina da soldi e i manager, dimostrando scarsa lungimiranza, cercano di ottenere il più possibile sulla breve distanza. Il risultato, in prospettiva, è quello di causare la fine del complesso. O comunque la sua trasformazione. I segni del disastro ci sono tutti: le liti, la stanchezza di Ian Gillan, le session discontinue e infruttuose, la voglia di staccare la spina.
Eppure, all’epoca i Deep Purple sono in uno stato di grazia tale che riescono comunque a dare alle stampe un lavoro ottimo che riscuote un enorme successo di pubblico, Who do we think we are. Si tratta di un buon album. Un lavoro che all’epoca pareva probabilmente di transizione, dopo i grandi capolavori precedenti, e che invece conteneva in sé i semi della distruzione.
Di lì a poco Gillan e Glover se ne vanno, i Deep Purple sosteranno per un po’ sull’orlo dell’abisso, prima che David Coverdale e Glenn Hughes arrivino a ridare ossigeno per un paio di dischi.Il primo è Burn ed esce il 15 febbraio del 1974, molto atteso tra gli appassionati del rock duro. Il lavoro è infatti il primo inciso dalla nuova formazione – denominata Mark III – e segna la rinascita di una band ormai data per morta. Alla fine del giugno del 1973, infatti, la notizia che era nell’aria da tempo finalmente arrivava: Ian Gillan, seguito da Roger Glover, abbandona i Deep Purple.
Al loro posto due new entry.
Dai Trapeze, band di qualche successo nel calderone rock di inizio anni ’70, arriva un cantante e bassista dal talento esuberante: Glenn Hughes. Il management è però chiaro: i Deep Purple si sono imposti come quintetto e quintetto devono rimanere.
La scelta cade su David Coverdale, un ragazzo affascinante che canta in modo amatoriale con alcune band. Per mantenersi fa il commesso di negozio a Redcar. Un pomeriggio pubblica un annuncio su “Melody Maker” alla ricerca di una band vera e registra un demo in cui – palesemente alticcio – canta alcune cover. Incredibilmente viene scelto e, da un giorno all’altro, si ritrova da commesso a frontman di uno dei complessi rock più importanti del mondo.
Per la critica, nonostante Burn sia un bel disco, con canzoni fortissime e con la novità del doppio cantante che viene ben sfruttata, i Deep Purple iniziano fatalmente a essere un po’ la rappresentazione di sé stessi. Se fino a Machine Head l’evoluzione dei Deep Purple era stata costante, con lavori sempre diversi tra loro e con una direzione musicale ben precisa, il processo con Burn viene un po’ meno. Pezzi come Burn e Mistreated sono comunque capolavori che entrano nel novero dei migliori pezzi dei Deep Purple.
L’equilibrio dura poco: Blackmore e Coverdale iniziano a litigare. Le scintille portano a un compromesso. Diviso tra pezzi tradizionalmente duri e passaggi pesantemente funk, Stormbringer risulta un disco poco coeso e vittima di una dicotomia progettuale che ne pregiudica la completa riuscita.
Presi uno per uno i pezzi sono quasi tutti validi. Tuttavia la band risulta priva di una vera direzione artistica, divisa tra brani quasi metal – la title track – e pezzi al limite dell’AOR americano (Hold On), che strizzano l’occhio all’airplay radiofonico d’oltreoceano. La frittata è fatta. Con un pretesto, Blackmore lascia e fonda i Rainbow, band dove può spadroneggiare come meglio crede e che ottiene buoni risultati, almeno inizialmente.
Il mercato si mostra piuttosto tiepido e Stormbringer non vende come i precedenti lavori dei Deep Purple. I ragazzi decidono comunque di andare avanti sulla strada del funk con l’arrivo del giovane e talentuoso Tommy Bolin. Afflitto da cronici problemi di tossicodipendenza, il chitarrista farà in tempo a licenziare il discreto Come Taste the Band, prima di morire di overdose, chiudendo con la sua tragedia la prima parte della carriera dei Deep Purple.
Il disco vende benino ma non benissimo; tuttavia, il peggio deve ancora arrivare. Tommy Bolin lega tantissimo con Glenn Hughes, non tanto per affinità musicali ma perché i due condividono certe abitudini riguardo alle sostanze stupefacenti. Glenn è un consumatore industriale di cocaina, mentre Tommy è appena entrato nel tunnel dell’eroina.
I Deep Purple iniziano a essere circondati da una pessima fama, intorno alla band si respira un’aria pericolosa e Tommy Bolin suona sempre peggio. Il 4 dicembre del 1976 Tommy muore a Miami, dopo un concerto, vittima di un mix di whisky, champagne, cocaina ed eroina. Per molti anni Come Taste the Band rimane la pietra tombale sulla storia dei Deep Purple; almeno fino agli anni Ottanta e all’ennesima rinascita.
Gli anni successivi vedono i vari componenti cercare il successo per vie svariate. Ritchie Blackmore può finalmente fare il despota coi suoi Rainbow, tuttavia dopo un paio di ottimi dischi il sound si annacqua. Glover, dal canto suo, collabora sia con Gillan che con Coverdale, per poi finire a suonare proprio coi Rainbow.
Jon Lord si tiene impegnato in mille progetti e suona anche coi Whitesnake, la nuova band di Coverdale. Ian Paice fa parte a sua volta dei Whitesnake e poi della band di Gary Moore. Gillan cerca prima invano e poi con qualche soddisfazione il successo solista, per poi finire con poca convinzione nei Black Sabbath, rivali storici.
Per anni i vari componenti giurano e spergiurano che i Deep Purple non si riuniranno mai. Le cose andranno diversamente, come vedremo nell’ultima parte della nostra monografia.