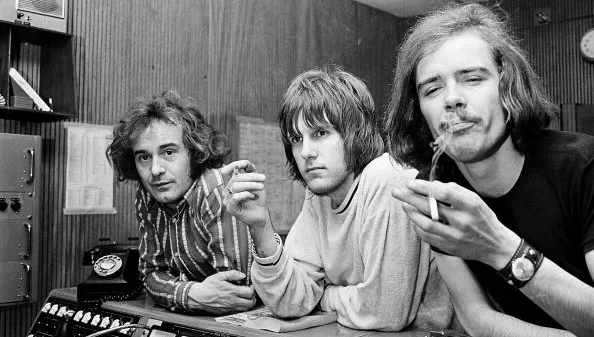Lo Sprechgesang, letteralmente “canto parlato” in tedesco, rappresenta una delle innovazioni più significative nella storia della musica del XX secolo.
Questa tecnica vocale (Sprechgesang), che si colloca a metà strada tra il parlato e il canto melodico tradizionale, nasce nel contesto della Seconda Scuola di Vienna all’inizio del Novecento, rivoluzionando il modo di concepire l’espressione vocale nella musica colta.
La nascita dello Sprechgesang viene tradizionalmente attribuita ad Arnold Schoenberg, che ne fa un uso pioneristico nel suo “Pierrot Lunaire” del 1912. In quest’opera, Schoenberg indica precisamente nelle partiture come le note debbano essere “più parlate che cantate“, creando un effetto di straniamento che diventerà caratteristico di questa tecnica. L’innovazione consiste nel mantenere l’altezza delle note solo momentaneamente, per poi abbandonarla immediatamente, creando un effetto di oscillazione continua tra parlato e cantato.
L’impatto dello Sprechgesang sulla musica del XX secolo è stato profondo
Alban Berg, allievo di Schoenberg, lo utilizza magistralmente nelle sue opere “Wozzeck” (1925) e “Lulu” (1935), dove la tecnica serve a intensificare il dramma psicologico dei personaggi. Berg sviluppa ulteriormente la notazione dello Sprechgesang, introducendo simboli specifici per indicare le diverse gradazioni tra parlato e cantato.
Nel secondo dopoguerra, lo Sprechgesang trova nuove declinazioni nella musica contemporanea. Compositori come Luigi Nono e Luciano Berio ne esplorano le possibilità espressive nelle loro opere vocali, integrandolo con tecniche elettroniche e nuove forme di notazione. La tecnica influenza anche il teatro musicale sperimentale, dove diventa uno strumento fondamentale per esplorare i confini tra musica e teatro.
Nel panorama contemporaneo, lo Sprechgesang ha trovato applicazioni ben oltre i confini della musica colta. Artisti come Diamanda Galás hanno portato questa tecnica nel contesto della musica sperimentale e dell’avant-garde rock. La sua influenza si può rintracciare anche in generi come il punk rock e il metal industriale, dove artisti come Nina Hagen hanno sviluppato stili vocali che devono molto alla tradizione dello Sprechgesang.
Tra gli esponenti più significativi che hanno utilizzato o sono stati influenzati dallo Sprechgesang troviamo:
- Nell’ambito classico contemporaneo:
- Cathy Berberian, che ne ha fatto un uso magistrale nelle opere di Berio
- Phyllis Bryn-Julson, interprete di riferimento per il repertorio di Schoenberg
- Christine Schäfer, celebre per le sue interpretazioni di “Pierrot Lunaire“
- Nel campo della musica sperimentale e popolare:
- David Thomas dei Pere Ubu
- Mike Patton, con i suoi esperimenti vocali nei Mr. Bungle e Faith No More
- Björk, che occasionalmente incorpora elementi di Sprechgesang nelle sue composizioni
- The Dresden Dolls, che mescolano elementi di cabaret e Sprechgesang
- Scott Walker, nelle sue opere più sperimentali
In continua evoluzione
Lo Sprechgesang continua a evolversi nel XXI secolo, influenzando nuove generazioni di compositori e performer. La sua capacità di esprimere stati emotivi complessi e di creare tensione drammatica lo rende uno strumento espressivo ancora vitale nella musica contemporanea. Le nuove tecnologie di elaborazione vocale hanno inoltre aperto nuove possibilità per l’applicazione di questa tecnica, permettendo manipolazioni e trasformazioni del suono che ne espandono ulteriormente le potenzialità espressive.
La tecnica rimane un elemento fondamentale nell’educazione vocale contemporanea, insegnata in conservatori e accademie musicali come parte essenziale del repertorio del XX secolo
La sua influenza continua a manifestarsi in forme sempre nuove, dimostrando come un’innovazione nata all’inizio del Novecento continui a stimolare la creatività musicale contemporanea, letteralmente “canto parlato” in tedesco, rappresenta una delle innovazioni più significative nella storia della musica del XX secolo. Questa tecnica vocale, che si colloca a metà strada tra il parlato e il canto melodico tradizionale, nasce nel contesto della Seconda Scuola di Vienna all’inizio del Novecento, rivoluzionando il modo di concepire l’espressione vocale nella musica colta.