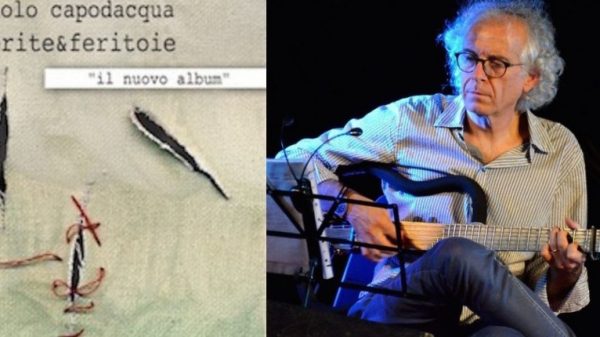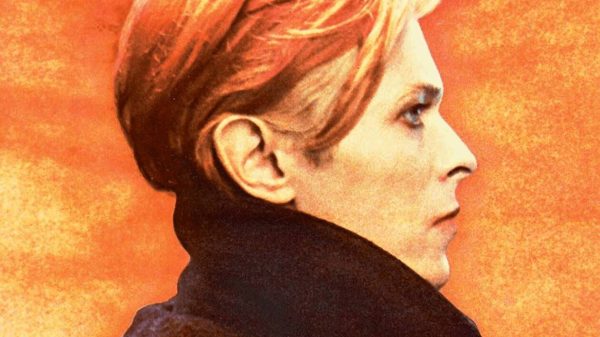1975, progressive rock inglese: l’anno del grande spartiacque, a spaccare in due metà esatte il decennio, tra capitalizzazione di fasti precedenti, innovazioni, crisi incipienti di crescita, sentori di qualcosa d’altro che premeva dal sottobosco underground.
Grandi rivolgimenti nelle band che hanno fatto da apripista a tutti gli altri: i Genesis senza Peter Gabriel, dopo il visionario The Lamb Lies Down on Broadway a cercare di darsi una direzione, medesimo problema per gli Yes, dopo l’altrettanto complesso Tales from Topographic Oceans, i King Crimson in pausa tattico-strategica, Emerson, Lake & Palmer vittime del loro stesso gigantismo, i Jethro Tull senza il bassista Jeffrey Hammond. In compenso i gruppi «minori» sfornano prove eccellenti, e il punk rock comincia, sotterraneamente, a battere i suoi primi colpi. A tutto campo, anche: a Londra Malcolm McLaren apre il primo negozio di accessori e vestiario punk.
Pink Floyd, Wish You Were Here
Forse «il» disco prog per eccellenza per i Floyd classici, formazione ancora con qualche parvenza di compattezza nel serpeggiante malumore che comincia a dividere seriamente Roger Waters da David Gilmour. Testi alla mano, si autodefiniscono qui «due anime perse a nuotare in una boccia per pesci rossi, anno dopo anno», per ritrovare «le stese vecchie paure», invocando un impossibile – e anche un po’ ipocrita – ritorno di Syd Barrett. Disco perfetto, a tratti struggente, ospite il poderoso Roy Harper alla voce, ma anche con una certa freddezza che marca il distacco da The Dark Side of the Moon e fa da spartiacque col futuro cupo e affascinante di Animals. Torneremo a parlarne.
Camel, Music Inspired by The Snow Goose
Più volte ripreso in mano dal gruppo di Burden, re-inciso anche completamente e portato in tour per le celebrazioni del caso da Latimer, è il disco – il terzo, in successione – più equilibrato e compatto dell’intera produzione Camel, anche se certe prove relativamente recenti hanno lasciato il segno. Una sorta di «prog da camera» senza opulenza, tutto finezze, sussurri e ricami di corde e tasti, a ripercorrere la storia scritta da Paul Gallico durante la seconda guerra mondiale, da noi nota come La principessa smarrita.
Greenslade, Time and Tide
Di recente sono uscite ottime Bbc Session e vari concerti recuperati, ma è il caso, in primis, di andarsi a riascoltare il potenziale inespresso in studio di questa grande band con due tastiere – Dave Lawson e Dave Greenslade – a cercare (e trovare) sempre l’incastro giusto. Nel ’75 esce questo quarto e ultimo lavoro per gli anni d’oro. I brani si sono asciugati, hanno preso una piega più pop, interviene un possente coro maschile gallese, ma la classe compositiva e strumentale è intatta. Da qui partirà la carriera solistica per Dave Greenslade.
Uriah Heep, Return to Fantasy
Il vero canto del cigno degli Uriah Heep «classici» con la potenza vocale intatta di David Byron, il primo con la presenza di John Wetton (a rimpiazzare Gary Thain, morto di overdose), che arrivava da Family e King Crimson, la crème del prog rock. Curiosamente, è anche il disco degli Heep che vende di più, all’uscita. Poi ci sarà il triste declino con un album zoppicante e privo di momenti veramente significativi come High and Mighty e Byron, allontanato tristemente dalla band, prenderà la via del tramonto.
Jethro Tull, Minstrel in the Gallery
Ian Anderson è notoriamente figura umorale e parecchio acida: in genere si diverte a fare e pensare esattamente il contrario di quanto ci si aspetterebbe da lui. Il disco del Menestrello, presentato in copertina da un quadro ottocentesco di Joseph Nash è opera complessa e avvincente, al riascolto mezzo secolo dopo. Fendenti rock, richiami alla musica antica, una lunga, complessa suite che va riassaporata, con una visione cupa e sardonica dei rapporti umani nei testi che non risparmia neppure se stesso, per una volta.
Strawbs, Ghosts, Nomadness
Strana creatura, gli Strawbs di Dave Cousins, tutt’ora attivi dopo infinite vicissitudini. Inizi nel segno di un vaporoso folk rock d’autore (con le prime prove della magnifica Sandy Denny, poi coi Fairport Convention), poi via via i tratti prog rock si accentuano, con piccoli capolavori come Bursting at the Seams o Grave New World. Il degno seguito di questi due lavori con Ghosts, ottavo capitolo. Splendide ballate, arrangiamenti sorprendenti, momenti più sferzanti e rock. La voce amara di Cousins che veleggia sicura su composizioni decisamente a fuoco come Grace Darling o Starshine/Angel Wine.
Gentle Giant, Free Hand
«I Jethro Tull erano gli unici amici che avevamo nell’ambiente», dichiara Kerry Minnear dei Gentle Giant ringraziandoli per aver introdotto il gruppo alla Chrysalis. Dopo un tour assieme. Free Hand è un disco perfettamente a fuoco, nella loro carriera, e mette in luce diverse anime musicali giunte a maturazione: ad esempio il rock puro di Time to Kill, le poliritmie frenetiche in Just the Same, la sofisticata elaborazione del brano che intitola, On Reflection, che è costruito come una fuga a quattro voci, la cameristica His Last Voyage, basata sull’alternanza di trii strumentali.
Caravan, Cunning Stunts
Le «astute acrobazie» del titolo (con un non troppo nascosto doppio senso piccante) del gruppo che discese per li rami dai Wilde Flowers canterburiani, come i Soft Machine, furono anche uno dei momenti rari in cui successo commerciale e qualità decisamente alta si incontrarono, in ambito prog albionico. Presentato da una copertina quasi floydiana, il disco con Pye Hastings e Dave Sinclair in gran spolvero si apre con uno dei classici a venire della band, The Show of Our Lives, poi entrano momenti più pop e risvolti classicheggianti, fino alla memorabile suite da diciotto minuti The Dabsong Conshirtoe, in sei parti.
Renaissance, Sheherazade
Nei segni inequivocabili di crisi e rivolgimenti del ’75, la formazione più classicheggiante e romantica del rock inglese progressivo, con la voce da fata imperiosa di Annie Haslam, rimane fedele a se stessa sfornando un album di ineccepibile bellezza, per molti fan il capolavoro del gruppo: con la London Symphony Orchestra, un coro, e la suite che intitola in nove movimenti che occupa un’intera facciata, già ben preparata dai dieci minuti pieni, sul lato a, di A Trip to the Fair, grande classico nei loro «live».
Gryphon, Rain Dance
Grande band del sottobosco prog inglese, purtroppo conosciuta solo dagli addetti ai lavori. Nel ’75 arriva la «danza della pioggia», con una splendida cover. Siamo in ambito prog folk medievaleggiante ma con innesti spiazzanti che invogliano ad approfondire la faccenda: i sintetizzatori e i fiati, sopratutto l’uso magistrale del fagotto, strumento ben di rado presente nelle formazioni inglesi (eccezione: gli Henry Cow). In chiusura, la maestosa suite da sedici minuti (Ein Klein) Heldenleben.
Van Der Graaf Generator, Godbluff
Il generatore a pieno regime, fase seconda, primo disco dopo la rifondazione, organico mantenuto: meno romanticismo prog, per quanto Hammill possa essere romantico, con la sua passione per il disagio e gli incubi, musica più serrata, asciutta e incupita ulteriormente, in quattro brani che verranno ripresi quasi sempre dal vivo, vedi alla voce The Sleepwalkers e The Undercover Man. Non a caso i punk rocker per loro proveranno gran rispetto, e per Hammill, di nuovo in piena creatività, una passionaccia (semi) nascosta.
Soft Machine, Bundles
Nel ’75 i Softs sono all’ottavo disco: veterani del jazz rock, formazione ampiamente rimaneggiata e in buona parte costruita coi transfughi dai Nucleus, gruppo speculare per intenti e direzione. Per la critica dell’epoca una sorta di azzardo «commerciale». Invece Bundles, riascoltato oggi, magari nell’edizione che comprende un concerto inedito del periodo, è ben più che una svaporato esercizio fusion. In formazione c’è, e solo qui, quel talento superiore e sfortunato che fu Allan Holdsworth, il suono, grazie anche a Karl Jenkins, acquista rilevanti componenti ambient e minimalistiche, come nella splendida Floating World.
Barclay James Harvest, Time Honoured Ghosts
Un disco bello e notevole, per certi versi assimilabile al coevo Cunning Stunts dei Caravan: i fan della prima ora non gradirono certo avvicinamento a formule melodiche più pop, forse frutto anche della trasferta per la prima volta in terra americana per le registrazioni, ma il riascolto mezzo secolo dopo svela finezze tastieristiche di assoluto pregio da parte di Wooly Wolstenholme e un superbo lavoro chitarristico da parte di John Lee. Moonchild è una delle pagine più delicate uscite dall’officina Barclay, magnifica anche Song for You. Consueta eleganza negli arrangiamenti e negli intrecci vocali, il declino è ancora lontano.
Henry Cow, Desperate Straights
Doppietta a tambur battente per il gruppo inglese molto amato anche dalle nostre parti, sulla scia di fortunati concerti (memorabile quello con Robert Wyatt in piazza a Roma). Una formula, la loro, che traghettava il progressive rock canterburiano verso le sponde più politiche e asciutte del Rock in Opposition a venire. La ricetta è quella delle origini, anche qui: art rock cameristico di impeccabile fattura, con aperture all’improvvisazione radicale, ricerca timbrica, vocine fragili e attonite, richiami a Kurt Weill, ma in Desperate Straights c’è la collaborazione paritaria con i favolosi Slap Happy, sulle stesse piste, ricambiando il favore di In Praise of Learning, stesso anno.
Curved Air, Midnight Wire
Molto amati in Italia, all’epoca, oggi finiti in un dimenticatoio ingiustificato, i Curved Air che presero il nome da un celebre brano di Terry Riley erano la creatura palpitante e briosa di una delle migliori front woman della storia del rock, Sonja Kristina. Qui c’è ancora i formazione Stewart Copeland, futuro batterista dei Police, e Darryl Way, piccolo Paganini del prog, e il disco si riascolta con piacere, anche se si avvertono, anche qui, i segni della «crisi di mezza età» del prog inglese: qualche scivolata un po’ troppo pop, meno grinta, per fortuna compensati da tre o quattro guizzi (ad esempio Pipe Dreams) degni di un passato glorioso.
Stackridge, Extravaganza
In Italia non se li è mai filati praticamente nessuno, se non i più solerti cacciatori di tracce prog e dintorni purché di pura provenienza albionica. Diciamo che gli Stackridge, più volte riformatisi nei decenni, possono assomigliare a dei Genesis d’antan col senso dell’umorismo, a mezza strada tra Frank Zappa e la commedia inglese. Questo è il quarto album, prodotto da Tony Ashton, formazione a settetto con nuovi ingressi, equilibrio instabile ma assai divertente tra jazz rock coevo, pop prog ben suonato, folk rock per accenni e quelle folate di follia cabaret rock che insaporiscono il tutto.
Nucleus, Alleycat, Snake Hips Etcetera
Il secondo corso dei Nucleus di Ian Carr, musicista e musicologo, trombettista sulla scia di Miles elettrico è degno d’ascolto quanto il fin troppo mitizzato primo periodo. Nel ’75 Ian Carr pubblica addirittura due dischi, Alleycat e Snake Hips Etcetera, con la medesima formazione. Chi ha nel cuore Mahavishnu Orchestra, i «cugini» Soft Machine del periodo centrale e In a Silent Way di Miles senz’altro tornerà a riscoprire con piacere questi due dischi considerati «minori» in cui domina un’atmosfera progressive jazz rock rilassata ma non svenevole, a volta caricata con piacevoli dosi di funk, e un solismo d’eccellenza sparso a piene mani.
Argent, Circus
Russ Ballard se n’era andato, quando gli Argent entrano in studio per questo concept album, e Rod Argent prese saldamente in mano le redini, con le sue tastiere sempre più orientate verso fughe e divagazioni jazzy, lasciando le parti vocali al nuovo innesto, l’eccellente John Variety. Poco apprezzato dai nostalgici della prima incarnazione del gruppo, Circus è invece un disco poderoso e fluente, attraversato da intermezzi strumentali tastieristici (piano Fender, moog, mellotron) che sembrano gettare un ponte tra certe dilatazioni floydiane e il jazz rock. Da riscoprire e riascoltare con attenzione.
David Byron, Take no Prisoners
Il tentativo (col senno di poi disperato) di Byron di intraprendere la carriera solistica lo vede ancora una volta affiancato da membri illustri della «sua» band, gli Uriah Heep: Lee Kerslake, Mick Box, Ken Hensley. Splendide ballate, curiose incursioni funk, rock tirato allo spasimo come da copione, o midtempo robusti e molto prog, perfino un tentativo di lambire il country rock, ma il tutto suona molto Heep, come un disco perduto e ritrovato. Non sarà più così, per lui, e gli altri Uriah Heep ormai a far parte per sé.
Mike Oldfield, Ommadawn
Per molti fan, forse il punto più alto toccato dallo specialista prog di suite in semi-solitaria. Nello stesso anno in cui esce la prima versione orchestrale di Tubular Bells, e dopo il pur notevole Hergest Ridge, da molti preferito nel suo lento dipanarsi alle sorprese continue delle Campane Tubolari, arriva un disco che profuma di arie gaeliche, con aperture radiose, e una facilità melodica che non sfora mai nella spossata leggerezza di tanta parte della produzione successiva.
Robert Wyatt, Ruth Is Stranger than Richard
Il difficile terzo disco per Robert Wyatt, dopo i fasti avvolgenti e amniotici di Rock Bottom, uno dei suoi capolavori. Qui ha il sopravvento la parte più jazzy e sperimentale del nostro, anche se corposi indizi non mancavano certo nelle due prove precedenti. Si parte con la patafisica «canzone della zuppa», Soup Song, dal vecchio carniere Wilde Flowers, si lascia spazio alla danzante Sonia del trombettista sudafricano esule Mongezi Feza, si piazza un colpo magistrale con la straziata poesia di Song for Che, dalla penna del grande Charlie Haden. Da riscoprire.
Peter Hammill, Nadir’s Big Chance
Nell’anno di Godbluff, dall’iperattivo e nevrotico Peter Hammill un disco solista efficace e spiazzante, cui peraltro collaborano gli altri «generatori». Le allucinate ballad di Hammill qui prendono un andamento secco e ritmico, come se il cantore di «case senza porte» e «squali creati per essere assassini» avesse captato nell’aria l’arrivo del punk rock. E infatti i punk apprezzeranno molto.
Steve Hackett, Voyage of the Acolyte
Peter Gabriel se n’è andato, e il chitarrista Hackett cerca di raccogliere idee ed energie con il suo esordio da solista, quasi interamente strumentale, con cammei vocali di Phil Collins e Sally Oldfield, decisamente in linea con i tipici sviluppi melodici sontuosi dei primi Genesis, vedi alla voce Star of Sirius. In effetti dai membri della band di Foxtrot arrivano significativi apporti: non quello di Gabriel, partito per altre sponde musicali.
Chris Squire, Fish out of Water
Primo e unico album «solo» per Squire, il mobilissimo bassista degli Yes classici scomparso nel 2015, con un suono unico, più modellato su versanti di agilità jazzistica solistica che sull’accompagnamento in tonica tipico del rock. Grandi ospiti: Bill Bruford dai King Crimson, Mel Collins al sax, Moratz alle sontuose tastiere che conferiscono un andamento decisamente sinfonico al lavoro. Punti di forza i quindici minuti finali di Safe, un ponte luminoso tra i Floyd e gli Yes degli «oceani topografici».
Brian Eno, Another Green World, Discreet Music, Evening Star
Il nuovo che avanza nel ’75 è sotto le insegne dell’eclettico «non musicista» Brian Eno, che piazza tre colpi anticipatori in dodici mesi: Another Green World, avant pop stranito con Robert Fripp, John Cale, Phil Collins, anticipatore a propria volta di Discreet Music, il disco che lascia un segno nella creazione delle note ambient. In più c’è Evening Star, maestoso e criptico secondo capitolo di «trattamento» dei loop sviluppati dalla sei corde di Fripp e dai suoi sintetizzatori.
(di Guido Festinese – link)