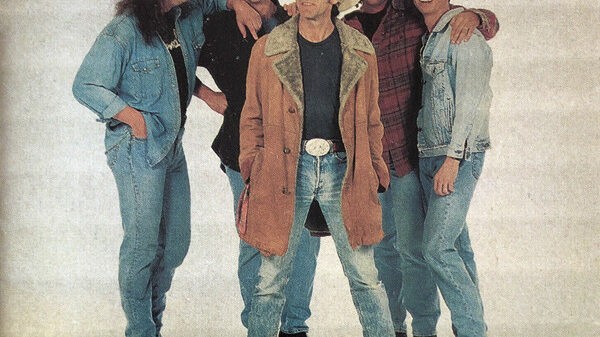Diverse persone mi hanno chiesto cosa ne pensassi – come se il mio parere contasse davvero qualcosa – del nuovo “fenomeno” della musica italiana: quell’Achille Lauro fresco di stampa con il suo ultimo “1969″.
In effetti, Lauro è quel tipo di personaggio che di attenzioni, anche se non si è avvezzi al genere, se ne attira in qualche modo, anche in abbondanza, e qualche parola in merito – per quanto valga – l’avrei voluta spendere da qualche tempo. Del resto, un artista che nel giro di un anno, da un Primo Maggio all’altro, è passato dal far dire di sé: “oh mio dio c’è pure ‘sto Achille Lauro” a “oh mio dio! C’è Achille Lauro!!!” qualcosa di buono deve averla pur fatta. Ma visto che sono un gran rompi scatole e non credo che “all that glitters is gold”, cercherò di tracciarne il profilo abbozzando una recensione del suo ultimo disco, appunto, “1969″.
Dico “abbozzando” perché in effetti è l’unica cosa che si può fare rispetto a quest’ultima fatica, soprattutto nella misura in cui è proprio quello che il suo ascolto trasmette a far emergere quest’idea: l’intento di “abbozzare un disco”, degno di questo nome, mai pienamente riuscito. Chiariamoci, 1969 può essere piacevole per diversi motivi, molti dei quali, probabilmente, si possono rintracciare proprio in quell’atmosfera che, anche quando sembrano volersi incupire – vedi in “Roma”, in versi mai troppo credibili come “Innalzato a morire su un colle / Trafitto nel costato a Vigne / Perito e intombato a Sempione / Risorto da qualche parte lì / A Montesacro” –, non può che risultare sempre scanzonata e priva di ogni possibile struttura o connessione.
Infatti, non c’è niente di regolato in questo disco: né il modo di costruire la canzone, né quello di scrivere testi e utilizzare le rime, né il tentativo di differenziare nettamente una canzone dall’altra o anche un suono dall’altro.
La stessa copertina esprime ampiamente, da un punto di vista visivo, quanto si traduce in musica durante l’ascolto. Ovvero, un’accozzaglia abbastanza confusa di suoni e parole, di immagini e riferimenti vari, di chitarre e auto-tune che tutto sommato risultano essere funzionali all’interno di un disco che dal nome vuole rifarsi a uno degli anni più significativi e – concedetemelo – barocchi della seconda metà del Novecento. Come detto più volte dallo stesso Lauro e dal suo fedele producer Boss Doms, quello che il duo cerca di portare in alcune canzoni del loro repertorio è l’essenza di alcune “icone di stile” degli anni passati: dalle rockstars ad auto di lusso, da grandi attori fino alle marche di pantaloni e giacconi di pelle…
Peccato che di quelle icone ci sia solo la patina superficiale che corrisponde a quello che resta intrappolato, per la maggiore, nella giungla della cultura pop ai tempi del web. Anche in questo caso quindi, il disco è un “abbozzo” di allusioni ad un repertorio appena sfiorato e mai approfondito, messo lì come una toppa fuori luogo e di (piacevole) cattivo gusto su un paio di pantaloni scuciti. E un insieme di abbozzi tentati e mal riusciti risulta essere anche il sound complessivo di 1969. Con canzoni tendenti alla trap ma troppo distanti anche da un genere che Achille Lauro, fino a un anno fa, rappresentava appieno.
Ci sono poi numerose allusioni a una sorta di post-punk che si frange costantemente su una struttura canora eccessivamente verbosa che crolla su sé stessa: andando fuori tempo, fuori metro, fuori rima, fuori tutto. E così con improbabili sequenze di “angelo; angelo; Castel San’Angelo; Nino D’Angelo”, in più di un’occasione – soprattutto quando per rendersi più raffinati si sposa il megacliché della lingua francese (e lì i “Mon amour” e “Je t’aime” si sprecano) – durante l’ascolto viene sulla bocca un sorriso di gusto che non so se sia un bene o un male.
C’è però anche del buono in questo disco e non mi riferisco al duetto con Coez che poteva essere risparmiato. Gli aspetti positivi di questo, piuttosto, si sposano perfettamente con la personalità di un artista che non riesce a stare antipatico (perlomeno non a me) neanche a volerlo. Tra pronunce sbiascicate e chitarroni pesanti – comunque gradevoli – emerge certamente il tentativo di fare qualcosa di nuovo. Tentativo sicuramente riuscito male, ma comunque riuscito. Si, perché il disco di Lauro, nelle sue mille sfumature abbozzate e nel suo essere un gran pastiche di cose messe lì, non si sa come, in effetti si presenta quale la mosca bianca che è in un panorama musicale che, per molti aspetti, appare noioso e sempre più scontato. Il disco lo si riascolta con piacere nonostante, come molti hanno detto, risulti essere una Rolls Royce estesa – anche se qui si passa a una fiammante e tiratissima “Cadillac” – per quasi un’ora.
Il sapore insipido, ridicolo, posticcio ma deciso di alcuni passaggi, richiama atmosfere degne della Factory di Andy Warhol, intesa nella sua accezione più burlesque e ironica. E se qualcuno ai tempi di Sanremo ha provato a teorizzare per la coppia Lauro/Doms un – del tutto improbabile – parallelismo con il duo Bowie/Ronson, dopo qualche ascolto tornano alla mente invece, i suoni dei primissimi dischi dei Velvet Underground, con i quali probabilmente c’è in comune una certa verve spontaneamente e disordinatamente provocatoria.

Non che le provocazioni di 1969 sconvolgano le orecchie e le coscienze di chi ascolta – diciamo che uno come Reed già nel 1969, per restare in tema, aveva superato da un pezzo le frasi a effetto da liceale dannato come: “Sono il diavolo ribelle, sono Dorian Grey” –, e ovviamente non si sta tracciando nessuna linea per alcuna rivoluzione musicale e culturale. Tuttavia, una bella scossa questa musica la può dare a chi si è sempre accontentato di ascoltare, in Italia, fino all’ultimo prodotto frutto del tubo di scarico dei Talent Show. E se spesso gli “artisti” di successo figli della televisione devono la loro fortuna al connubio mediatico con i giudici di una competizione, o all’intrattenimento da circo delle infinite battaglie in nome della musica, Lauro deve la sua fortuna soltanto a sé stesso.
Con suoni “nuovi” rispetto al suo recente passato, si è reso certamente più “accettabile” rispetto all’idea del trapper nudo e crudo, facendolo in un modo del tutto personale, stravagante ma certamente interessante.
Ad ogni modo, 1969 non è un disco memorabile, e non è neppure un bel disco nel senso puro del termine, ma certamente ha una sua coerenza interna e, lo confesso, lo si riascolta davvero volentieri. È anche vero però che dopo due o tre canzoni si ha voglia di passare a qualcosa di meno simile a una parodia di sé stessi e parodiarsi dopo solo una manciata di canzoni è un brutto segno.
L’impressione complessiva, a volte, è quella di trovarsi di fronte a un fenomeno apprezzabile più per la propria singolarità che per effettivi meriti. Del resto, chi scriverebbe e renderebbe memorizzabile una canzone in cui, per metà del testo, la parola “zucchero” è ripetuta circa 79 volte? Simbologie occulte? Nah!
Matteo Palombi – Onda Musicale