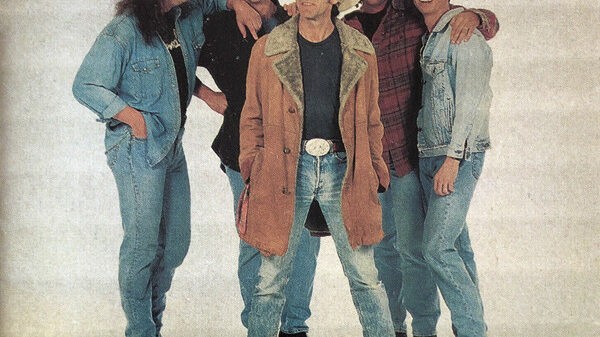L’”intro” è una nenia inquietante ci accoglie con un giro di piano ed una voce malinconica per la presentazione del lavoro dei Misero Spettacolo.
Dopo l’introduzione il primo brano, vero e proprio, è “L’Italia dei pensatori” con la sua intro ben ritmata che mischia tratti quasi surf music e ska. Una voce quasi sbronza ci descrive l’immobilità del Paese dei cittadini italiani medi. Un Paese che aspetta la rivoluzione “sul divano in casa e in televisione o al massimo fissando il suo nuovo cellulare tra un’applicazione nuova e l’altra da scaricare” oppure esaltando gli atleti di turno. Delicate note, quasi in punta di piedi, pongono accenti sulle ironie e contraddizioni di questo Paese.
Devo dire che il nome di Giorgio Gaber (“Io non mi sento italiano” in primis) sembra venire fuori dalle righe del testo sempre più con il passare dei minuti soprattutto con il monologo finale sul “pensiero che salverà in nostro Paese”. In “Pressapochista” viene presentato un altro ritratto spietato con pennellate punk – rock e sfumate con una voce ironica ed una sezione ritmica che funge da cavalletto a sorreggere il tutto.
“Io scrivo la mediocrità dell’umanità” è una frase che non esito a definire come perfettamente riassuntiva sia della canzone che dell’album. “Strategie del benessere” mischia un simil – bluegrass ad una canzonetta/marcetta per bambini dove, il fumare venti sigarette al giorno, “è la nuova strategia dello star meglio qui” ed i ventisei pazienti del centro benessere attendono di essere massaggiati e calcolati anche se c’è da pagare.
“Per guadagnare i soldi che da noi poi spenderai” per cui non si deve ascoltare un tal Pier Paolo (direi Pasolini) “che prima o poi finirà male anche lui”. Una piccola marcetta, poi, non si lascia stare neanche la riunione di un partito.
A questa segue “Canzone di profilo” con le sue schitarrate decise e brevi intervalli di bacchette tintinnanti che evidenziano come il cantare di profilo non faccia mai sfigurare. Non per niente, secondo la madre, diceva che in questo modo si assomigliava a Dante. Inoltre si raccomandava tanto di “non mostrare mai l’altro lato, fila dritto e impostato, altrimenti verrai punito”.
La metafora è dunque chiara, mostrare la parte di sé socialmente accettabile perché così ci è stato inculcato in testa da norme, figure e società. La nostra maschera insomma. Con “MWM” si ha un brano quasi jazz che si perde nelle mille sfumatura che il termine “verità” possiede. Perciò “la verità è che ogni passo ha un suo suono, ogni suono ha il suo eco” e “i segni mappano la pelle e che i ricordi scrivono le spalle”.
Una mappa di esperienze e dolore per non perdersi. Non mancano brevi intermezzi di conversazioni che coinvolgono “avvocati”, “fisica moderna”, “ingredienti” e “pollice verde” e qualche velata accusa e Dio che fa da spettatore a quello strano spettacolo che è la nostra esistenza su questa Terra avvelenata.
Da ricordare la citazione di Totò alla fine, “e io pago” (tratto dal film “47 morto che parla” del 1950 diretto da Carlo Ludovico Bregaglia). “Mozy” si distingue per il suo rivolgersi direttamente ad una persona piuttosto che ad una moltitudine oppure ad un’entità astratta. La tensione è palese e, non per niente, riesce “solo a balbettare frasi fatte senza senso finché riuscirò a cantare” per poi sentire e vedere sui suoi “passi stanchi e storti”. Una canzone di rimpianto per qualcuno che si è perduto chissà dove, ma che ha lasciato dei segni indelebili.
È poi il turno di “Mia cantina”, intro a suon di echi e wah wah con un giro di piano quasi da saloon, dove si parla di come si riesca a trovare riparo dal “Paese dei malcontenti” nella propria cantina/fortezza del proprio essere.
Ritornello con voce femminile in controcanto estremamente catchy e non lascia indifferente nessuno. Verso la fine si sentono anche dei vaghi echi di Elvis Presley grazie alla voce femminile che si fa più blues mentre il ritmo e la voce maschile si fanno più beat ricordando Il Balletto di Bronzo degli esordi (“Girotondo”).
In “Ppp” chitarra e basso malinconici s’intrecciano con la voce inquietante che narra le vicende della democrazia e di Pilato “il carnefice, le mani ho lavato” che decide la vita e la morte degli sventurati posti al suo giudizio.
Ritornello più lanciato che invita alla diffidenza dei costrutti sociali simili a questi per poi ritornare al giro iniziale, più “allegro” e col basso in maggior evidenza. Come la verità, anche guerre e stragi si perdono nella folta nebbia dell’indifferenza. Tastiere anni ’60 in stile Doors condiscono la parte finale prima dell’ultimo ritornello. “Daltonismo cronico” si distingue per ritmi e melodie in equilibrio tra blues e country, strizzando l’occhio a flamenco ed elettronica.
La frase, vagamente nichilista, “io non vedo più l’orizzonte, ho sempre un monte di fronte. Spargono sale sulle orchidee, orinano sulle mie idee” apre il brano. Complessi tappeti sonori si stendono ai piedi dell’ascoltatore mentre la voce si fa sempre più decisa per poi interrompersi, quasi, improvvisamente.
Tra i brani più interessanti a livello strumentale “Daltonismo cronico” svetta su tutti. Come un melanconico jazz si apre il sarcastico brano “Frignone” intervallato da esclamazioni del tipo “ma perché non riesco a suonare un po’?”. Ironia e vintage musicale nello stesso momento e controtempi alla fine. Segue uno dei brani più poetici del disco, “L’uomo di foglie”, che con uno stupendo giro di piano fa vedere all’ascoltatore il raccolto di foglie da mettere in valigia per non perdere i ricordi.
“E non mi accorgo che passo la vita a rincorrere foglie morte spazzate dal vento di Maestrale. Non mi accorgo che tra quelle foglie ti nascondi tu portata qui da un vento di Libeccio“ è uno dei maggiori momenti poetici della canzone e dell’album. Una canzone intima che colpisce dritta al cuore e fa viaggiare la mente lungo il viale dei ricordi. Dopo viene “Transumanza”, con dei giri quasi orientaleggianti e frasi di benvenuto che conducono l’ascoltatore in un brano più psichedelico con interferenze folk.
Conclude il disco la classica ballatona “Emigrante” di gaetana memoria. Che dire di quest’album? Ottime sonorità vintage, jazz e cantautorato condito dalla salsa agrodolce dell’ironia e della satira italiana sul nostro stesso Paese a forma di stivale (stivale che sembra prenderci a calci). Per usare qualche terminologia da cinefilo considero l’album di “fantozziana memoria” e lo consiglio caldamente.
Un invito ad aprire gli occhi sulla realtà con un sorriso beffardo ed una piccola lacrima.
Vanni Versini (Onda Musicale)