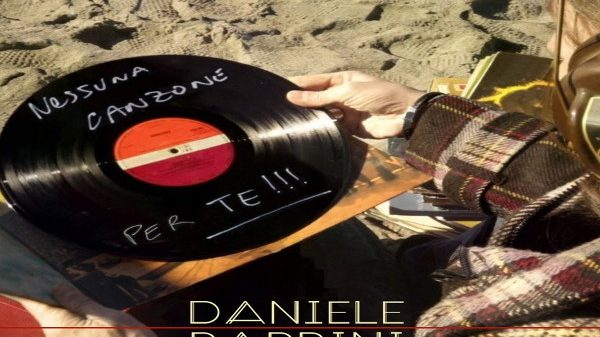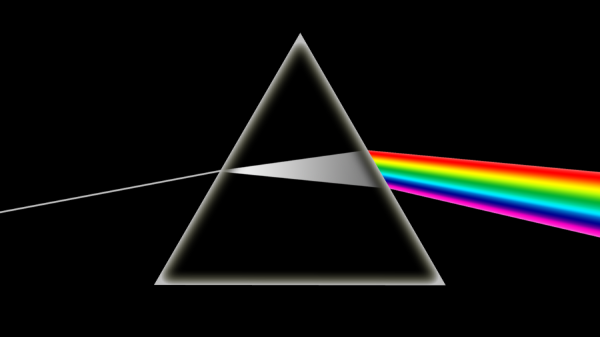Nel mese di ottobre del 1989 a Reading (Regno Unito) nascevano gli Slowdive, una formazione che è sempre stata fuori dagli schemi rispetto a tutta la musica corrente.
Erano troppo pop per essere presi seriamente in considerazione dalla scena grunge e troppo psichedelici per essere ben considerati dal pubblico mainstream, di fatto sono rimasti schiacciati in una definizione – shoegaze – che all’epoca suonava più che altro come uno scherzo di cattivo gusto. La band si è sciolta nel 1995 e ricostituita nel 2014, dopo 20 anni di inattività.
Ecco la nostra scelta. (tratta da Shoegaze Blog)
Here She Comes (1993)
Una canzone priva dell’epica che caratterizza da sempre gli Slowdive, eppure perfettamente in grado di svelarne l’essenza: il racconto di una solitudine in mezzo a una folla indifferente. Quante volte ci è successo di trovarci in una situazione simile? Neil Halstead la racconta così.
Golden Hair (1991)
Un classico di Syd Barrett che è diventato un classico dei live degli Slowdive, assolutamente a proprio agio nel trasformare questo brano in un capolavoro dream pop, ancora oggi centrale nella definizione del suono shoegaze.
Blue skied an’ clear (1995)
Il folk siderale di Pygmalion non può fare a meno del calore di Blue skied an’ clear, delle sue linee vocali sottili come un sussurro disperso nella notte, delle sue aperture melodiche dilatate, della sua progressione gentile.
Avalyn I e II (1990)
Chi non c’era, non potrà capire l’atmosfera di totale sospensione che si era creata al Magnolia di Segrate durante uno spettacolare live degli Slowdive del settembre 2017. Ecco: quella sera il post rock di Avalyn ha segnato lo scarto decisivo, trasformando un’esibizione importante in un concerto emozionante.
Rutti (1995)
Rutti è un brano molto particolare, in cui quello che non c’è conta forse di più rispetto a quello che c’è. È un crescendo che dialoga costantemente con il silenzio intorno, creando qualcosa che per gli altri è semplicemente melodia e che per noi è soltanto – si fa per dire – magia.
The Sadman (1991)
L’inizio proviene dalle lande desolate di Disintegration dei Cure, per via del basso gotico e marziale che sembra rotolare su un piano inclinato sull’abisso. Il ritornello però squarcia l’atmosfera cupa e sposta il gruppo in direzione di una psichedelia satura di effetti. Per il chitarrista Christian Savill è il pezzo meno riuscito del gruppo. Esagerato.
Star Roving (2017)
La canzone del ritorno dopo ventidue anni di silenzio è il punto e a capo che serviva per ricordare a tutti che quando si parla di shoegaze gli Slowdive sono davanti a tutti gli altri. Sembra quasi che Halstead voglia dire: “Grazie a tutti per l’ottimo intrattenimento di questi anni, ma ora tocca a noi”. E Star roving, con la sua esuberanza chitarristica e la melodia a presa rapida, ci ricorda che nessuno è come gli Slowdive.
Brighter (1991)
Una ballata dream pop, uno standard ben codificato della prima fase della carriera degli Slowdive. È forse una delle canzoni meno celebrate della loro discografia, ma la grandezza di una band si misura anche dallo spessore delle tracce minori.
No longer making time (2017)
Probabilmente è la canzone col miglior ritornello di tutto l’album Slowdive. In un certo senso è la riedizione di When the sun hits: c’è lo stesso concetto di alternanza tra strofa leggera e ritornello pesante, anche se nel caso di No longer making time l’arrangiamento è meno grezzo e più raffinato.
Souvlaki Space Station (1993)
A dimostrazione dell’estrema versatilità della formula degli Slowdive, Souvlaki Space Station è un brano che ha molte più sfumature dub che dream pop. C’è un groove insolito per un gruppo shoegaze – di solito si punta ad altro – che si adatta perfettamente alle sonorità cosmiche della band.
Dagger (1993)
Una delle più intense canzoni sulla perdita di un amore, sull’accettazione dei propri errori, su certe ferite che si incollano sull’anima – e non c’è cicatrice che venga in soccorso per metterci una pezza e consentirci di andare oltre. Dagger è la rivelazione del talento folk di Halstead, un capolavoro per voce e chitarra acustica, una confessione malinconica che racconta un’intera vita senza tralasciare proprio nulla. Senza chiedere sconti davanti alle proprie colpe.
Sugar for the pill (2017)
Una delle più intense canzoni sulla perdita di un amore, sull’accettazione dei propri errori, su certe ferite che si incollano sull’anima – e non c’è cicatrice che venga in soccorso per metterci una pezza e consentirci di andare oltre. Dagger è la rivelazione del talento folk di Halstead, un capolavoro per voce e chitarra acustica, una confessione malinconica che racconta un’intera vita senza tralasciare proprio nulla. Senza chiedere sconti davanti alle proprie colpe.
Crazy for you (1995)
Il soliloquio di Neil in Pygmalion è un post rock atmosferico e rarefatto di poche note e pochissime parole, ultimo lascito prima di un addio che all’epoca pareva irreversibile. La malinconia degli Slowdive si trasforma a posteriori in una sorta di requiem per una storia – musicale, sentimentale, personale – finita ma che ancora non smetteva di spaccare il cuore e di sollecitare rimpianti.
When the sun hits (1993)
In un certo senso When the sun hits è la cosa più vicina al grunge che sia mai stata realizzata dagli Slowdive. La struttura infatti è quella tipica di un certo tipo di rock alternativo americano: un’alternanza assoluta tra pianissimo e fortissimo, con distorsioni che piovono a cascata su una melodia fragile e struggente. Certo, resta pur sempre un brano shoegaze, quindi c’è tutta l’epica timida che sappiamo e le linee vocali che sono sussurri nascosti tra le note. A differenza dei diretti concorrenti dell’epoca, negli Slowdive di When the sun hits c’è meno veleno, meno dolore, meno disgusto: in compenso, ci sono più sogni da inseguire e più malinconie da rivelare.
Slomo (2017)
Ricordo ancora quel giorno. Anzi, quella notte del 5 maggio 2017: a mezzanotte e un minuto ho messo play su Spotify per ascoltare il nuovo album degli Slowdive. La prima traccia è Slomo, capolavoro di grazia e raffinatezza, con un giro di basso bellissimo e protagonista, che sembra galleggiare tra i mille riverberi delle chitarre, delle voci, dei synth, della batteria. È questa canzone, più di Star roving e di Sugar for the pill, a raccontare il ritorno perfetto degli Slowdive, l’assoluta necessità di riaverli con noi, il bisogno di riprendere quel discorso che era stato interrotto troppo presto e troppo a lungo.
Celia’s dream (1991)
Nel 2004, durante un’intervista amarcord incentrata sugli Slowdive – all’epoca ben lontani dal pensare a una reunion – Rachel Goswell fu piuttosto tranchant nei confronti dei testi della band: “Molti erano spazzatura, non è un caso che non siano mai stati stampati sui libretti. Celia’s dream parlava per esempio di un coniglio“. Chissà se ancora oggi la pensa così. Di sicuro, quel povero coniglio ha trasformato per sempre il dream pop e ha affinato il suono della band (oltre che quello di milioni di altre band arrivate dopo). Mica male.
40 days (1993)
La prima volta che ho ascoltato questo pezzo è stato nel 2002. L’etichetta berlinese Morr Music aveva fatto uscire una bellissima compilation tributo agli Slowdive, Blue skied an’ clear, con alcuni dei nomi più significativi dell’indietronica dei primi anni Duemila. Tra questi, i Lali Puna, uno dei miei gruppi preferiti in assoluto. La loro versione di 40 days è così struggente, quadrata e compiuta che non farebbe pensare a una cover. Per come l’ho vissuta io, questa reinterpretazione è stata una sorta di sveglia: “Che cosa ti stai perdendo, ragazzo?”. In effetti, all’epoca il mio culto ancora acerbo per questa band si era fermato a Just for a day – ero più interessato al rumorismo di Kevin Shields, a dirla tutta. Così, appena ho ascoltato la versione originale di 40 days, il mio amore passeggero per lo shoegaze è diventato un sentimento consapevole e, soprattutto, definitivo.
Machine gun (1993)
Il racconto della musica degli Slowdive non può certo non passare dall’intreccio di voci di Goswell e Halstead, opposte ma complementari: lei è l’alba, lui è il tramonto, timbri perfetti e sfumati per una musica fatta di coriandoli di luce che flirtano con l’oscurità. Machine gun è l’esempio perfetto della narrazione sonora della band: una dicotomia sogno-risveglio in cui i contorni non sono mai netti, come un tuffo lento che sembra non finire mai. (Che non vuoi che finisca mai). Rachel e Neil capovolgono continuamente le prospettive della canzone – prima liquida e delicata, poi concreta e drammatica – in una sorta di girotondo che si rinnova a ogni strofa e a ogni ritornello, trascinandoci in questo vortice di strumenti che crescono di intensità e di emozioni che vanno in loop.
Catch the breeze (1991)
Per usare le parole di Christian Savill, Just for a day è stato un album molto difficile per gli Slowdive. “Avevamo messo tutte le nostre canzoni migliori in tre ep quell’anno. C’era una pressione enorme per realizzare un album senza che avessimo davvero il tempo per comporre o per fare le prove”. Sempre Christian sostiene che il suo brano preferito da suonare dal vivo è Catch the breeze: “La parte finale ha un suono enorme”. In effetti quella coda strumentale che spezza in due la traccia è il benchmark definitivo dello shoegaze per i decenni a venire: tutti hanno provato a imitare quel flusso infinito di distorsioni, pedalini, feedback ed emotività, nessuno è mai riuscito a eguagliarne l’intensità assoluta. Gli Slowdive lasciano andare i suoni e costruiscono così il loro mito emozionale e irraggiungibile.
Alison (1993)
Fa un certo effetto, anche a distanza di così tanti anni, leggere i commenti della stampa britannica su Souvlaki: “I would rather drown choking in a bath full of porridge than ever listen to it again. Slowdive? More like slow death”, si leggeva su Melody Maker. Il porridge peraltro è andato di traverso anche a qualche collega musicista: Ritchie Edwards, chitarrista dei Manic Street Preachers poi scomparso nel nulla il primo febbraio 1995 (e dichiarato presunto morto nel 2008), ci era andato giù ancora più pesante, dicendo di odiare gli Slowdive più di Hitler. Che si trattasse di una banale trollata o di un odio cristallino e fuori dai denti cambia poco: il punto è che questa band era stata ridotta al rango di reietta della musica pop. Alison è la canzone che più di tutte racconta la storia di un gruppo che non ha avuto punti di riferimento ai quali aggrapparsi: dove volevano andare questi ragazzini timidi in un mondo all’epoca dominato da rap e grunge? Persino lo shoegaze non era una consolazione: si trattava di un genere mai nato per davvero, rimasto incastrato all’interno di una scelta impossibile da compiere – più rumore o più melodia? – e che per questa indecisione non è riuscito a trovare una posizione mainstream in grado di preservarne la purezza d’intenti e di garantirne al tempo stesso un futuro economicamente sostenibile.
Di fatto, Alison rappresenta uno dei pochi tentativi davvero riusciti di dream pop in cui la parte pop non si mangia quella dream, un equilibrio di psichedelia e fruibilità con la voce in primissimo piano – una sorta di bestemmia per lo shoegaze – e un arpeggio che vale una carriera intera. A trascinare nel mito questa canzone c’è senz’altro il testo, che oppone un realismo quasi scioccante a una melodia estremamente romantica: la descrizione di una ragazza persa nei suoi viaggi stupefacenti e nelle sue sigarette sempre accese, una vita di nebbia e incertezze in cui non resta altro che ridere senza freni mentre intorno tutto va a rotoli, mentre intorno niente ha davvero importanza.
(di Manfredi Lamartina – link)