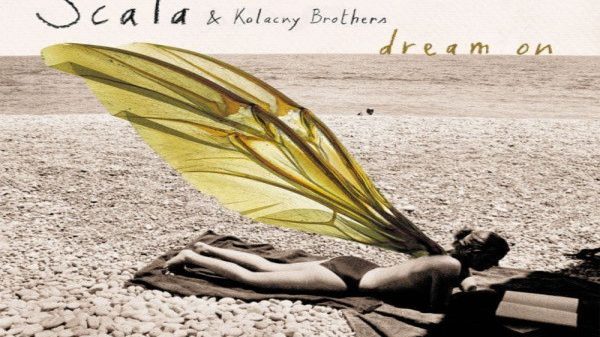C’è poco da fare: ai rockettari di ogni generazioni alcuni nomi scatenano misteriose allergie. Senza arrivare agli estremi di Nickelback o – pietà – dei Måneskin, quello dei Coldplay è uno di questi.
I Coldplay nascono idealmente nel 1996, alla festa delle matricole della University College di Londra. Lì si conoscono Chris Martin e Jonny Buckland, e già qui si capisce come il rock sia cambiato dai tempi d’oro di fine anni Sessanta. Non c’è nulla di maledetto nella loro idea di dar vita a una band. Chris è un rampollo della Londra bene e ha preso lezioni di pianoforte da quando aveva cinque anni.
Ha la faccia pulita da bravo ragazzo e non serve tirare in ballo Ted Bundy: lui lo è davvero. Jonny vuole fondare una band ma la sua unica esperienza è in un gruppetto hip-hop. Chris inizia a scrivere canzoni, mentre la band si arricchisce in breve degli altri due elementi, Guy Berryman e Will Champion. La vicenda di Will è emblematica del periodo: suonicchia una serie di strumenti, che però sono già tutti assegnati.
Champion non si perde d’animo: manca un batterista e lui impara in tre mesi, accomodandosi così dietro i tamburi. Non è chiaro se Will sia un genio musicale o se per la musica dei Coldplay non sia richiesto un fuoriclasse delle bacchette. Noi propenderemmo per la seconda ipotesi.
La band è così pronta e, col nome di Starfish, inizia a esibirsi all’alba del 1998 in qualche club inglese, con un repertorio scarno e un lungimirante basso profilo.
Mettiamoci ora nei panni degli appassionati di Brit Pop albionici del periodo. Gli anni Novanta sono stati un periodo d’oro, forse l’ultimo capace di dar vita a un grande movimento rock britannico. Ora però la rivalità tra Oasis e Blur ha portato le due maggiori star a impantanarsi in una sorta di sperimentalismo che non accontenta nessuno. I Pulp, vero faro del genere, hanno smarrito la vena e i Verve si stanno sciogliendo.
I Radiohead, che fanno parte del movimento solo in parte e sono forse l’ultima grande intuizione rock della storia, hanno rinnegato la psichedelia di OK Computer per tuffarsi in acque sperimentali dove è difficile seguirli senza annaspare. La timida avvisaglia di un altro Brit Pop, depresso e intonato alla nuova generazione, è in una band dimessa e autoironica, i Travis.
Il futuro sembra loro, con le tipiche melodie sfuggenti, un’immagine divertente e un solido sound. E invece, a fare il botto e i milioni, saranno proprio gli Starfish, che adesso si chiamano Coldplay e hanno firmato per la Parlophone.
Mentre l’umanità si prepara a cambiare secolo, terrorizzata dal Millenium Bug – pare preistoria, vero? – i Coldplay registrano l’album di debutto. Parachutes vede la luce proprio alla fine del secolo, ma uscirà solo a luglio del Duemila. Nonostante i due EP Safety e The Blue Room siano passati inosservati, Parachutes ottiene subito un buon successo. Non solo, questo album scarno nella grafica e ancor di più nei suoni, sarà destinato a diventare, a suo modo, una pietra miliare di inizio secolo.
La copertina raffigura un mappamondo giallo su sfondo nero che gira; a un’occhiata distratta, pare di vedere la luna, la stessa a cui uno spaurito Chris Martin pare ululare nel video di Yellow. Ed è proprio il corto che accompagna il singolo, in un’era non lontana in cui i video godevano ancora di grande importanza, un fattore del successo dei Coldplay.
Parachutes, infatti, è un disco leggero e profondo insieme, romantico e timido, simbolo di una generazione che inizia a chiudersi dopo decenni di sbruffoni rock. E l’immagine naif di Martin, bagnato come un pulcino su una fredda spiaggia inglese, rappresenta l’ingenuità di tutto il progetto Coldplay.
L’apertura del disco spetta però a Don’t Panic, breve anthem che contiene tutta la poetica della fase iniziale del gruppo. La voce di Chris Martin – tecnicamente un baritenore – è carezzevole e profonda nelle strofe, per aprirsi al caratteristico falsetto nel ritornello. L’influenza di Thom Yorke è palese e riconosciuta da Chris, la sua sembra una versione più educata e meno inquietante del bardo dei Radiohead.
Don’t Panic è un gioiellino, non banale anche a livello strumentale, con la chitarra di Buckland che punteggia con convinzione e sciorina persino una parte slide quasi psichedelica.
Shiver è più mossa, più rock nel senso comune del termine, con la chitarra e la sezione ritmica in evidenza. Martin è sempre dimesso nel ritornello, una sorta di indolenza interpretativa che è il suo iniziale marchio di fabbrica. Quando il pezzo prende quota, però, Martin pare omaggiare un altro suo nume tutelare, Jeff Buckley. All’epoca il confronto, che oggi suona come una bestemmia, è in realtà piuttosto credibile.
Il buon attacco prosegue con Spies. L’inizio acustico pare preso di peso dai Radiohead più cupi, anche se la voce di Chris Martin non riesce ad avere lo spleen esistenziale di Yorke. Si tratta di una ballata sontuosa, con un bel crescendo e che cita a piene mani i Radiohead di Street Spirit; forse manca il colpo del KO, ma Spies è comunque un pezzo che si staglia ben al di sopra della media.
Sparks prosegue sulla falsariga acustica di Spies. L’andamento è lento e indolente, la voce di Martin una carezza ruvida al punto giusto. Gli strumenti sono tutti al posto giusto, nessuno vuole strafare e nessuno rimane indietro. Manca forse anche qui la scintilla del genio, ma il brano scorre via benissimo, in una sorta di euforica depressione.
Siamo al cuore del disco. Yellow è infatti il pezzo che impone, anche grazie al video di cui si diceva, i Coldplay all’attenzione degli appassionati. Una ballata classicissima con la trovata di una chitarra distorta che accompagna ritmicamente l’intro. Il falsetto di Martin è proverbiale e poco importa che il testo sia talmente banale e naif da risultare quasi una sfida all’ascoltatore.
In Yellow tutto suona al posto giusto al momento giusto; un miracolo, una congiuntura astrale che rende un testo che sarebbe rifiutato anche in corso per cantautori per corrispondenza un successo epocale. E impone Chris Martin come il sex symbol stralunato di inizio millennio, quello da ascoltare tra una benzodiazepina e un attacco di panico.
Un video dalle atmosfere surreali e un’intro di piano geniale ci portano a Trouble, forse il pezzo da novanta di Parachutes. Chris Martin ci fissa sempre spaurito, ma ha già imparato a guardare in camera senza l’imbarazzo di Yellow: il ragazzo cresce in fretta. Il pezzo è un capolavoro di Chamber-Pop. L’alternanza tra la strofa, cantata su un filo di pianoforte, e l’ingresso di tutta la band è qui al massimo dello splendore.
Un cliché che sarà replicato dai Coldplay negli anni, con risultati via via più disastrosi. In Trouble, però, tutto suona alla perfezione e non si fatica a capire come una band di ragazzotti all’esordio possa aver conquistato il pianeta all’alba del Terzo Millennio.
La brevissima Parachutes, piacevole bozzetto folk, introduce la seconda parte del disco. Che, per forza di cose, va un po’ in discesa. High Speed è un pezzo che gioca la carta della psichedelia, pur senza discostarsi troppo dal modello Radiohead come faro. Il brano fatica però a rimanere impresso nella memoria.
We Never Change parte come una ballata folk, quasi alla Neil Young, per poi arrotarsi in un ritornello che evoca ancora Jeff Buckley. La sua forza è nella semplicità, con quell’andamento lento e acustico che somiglia a tutto e a niente; il suo punto debole, la stessa semplicità, eccessivamente naif nel testo:
I want to live life/Never be cruel/I want to live life/Be good to you
I want to fly/And never come down/And live my life/And have friends around
Everything’s Not Lost è la degna chiusura di Parachutes; un brano in cui Chris Martin gioca a fare il crooner, una sorta di versione British e dimessa di un Billy Joel o un Elton John. Quando entra il resto della band i toni tornano abbastanza dalle parti degli altri brani, con un mood piacevolmente solare rispetto al resto del disco.
Attenzione, però, a togliere il disco dalla puntina: c’è ancora spazio per una ghost track, Life is for Living, che però non aggiunge nulla di più.
Parachutes, come detto, vende molto bene e fa dei Coldplay un piccolo fenomeno e l’ennesima Next Big Thing della Gran Bretagna. Martin e soci, però, hanno le idee chiare: loro non vogliono essere i nuovi Oasis o i nuovi Radiohead. Loro vogliono conquistare il grande mercato del pop, quello dove si fanno i soldi a palate. E così sarà.
Dopo A Rush of Blood to the Head, ambizioso – e un tantino pretenzioso – seguito di Parchutes, i numeri si faranno davvero imponenti. La qualità è ancora alta, ma i nostri stanno solo preparando il terreno affinché crescano ancora. Chris Martin, da paladino un po’ depresso e un po’ sfigato delle nuove generazioni, diventa una star.
Sposa Gwyneth Paltrow, infesta le copertine dei magazine ed è un frontman sicuro di sé fino all’eccesso. La musica, ça va sans dire, finisce lì, col crescere del conto in banca. Da allora i Coldplay diventano una macchina da soldi, allestendo levigati mappazzoni pop; suoni perfetti e cristallini che non portano da nessuna parte, se non in cima alle classifiche. E scusate se è poco.
Parachutes, però, rimane lì, con le sue tante ingenuità e i suoi suoni perfetti. A far rimpiangere quello che poteva essere e non è stato, con buona pace dei milioni di sterline e delle prime pagine delle riviste.
E a farci capire che, forse, quelli ingenui eravamo noi.