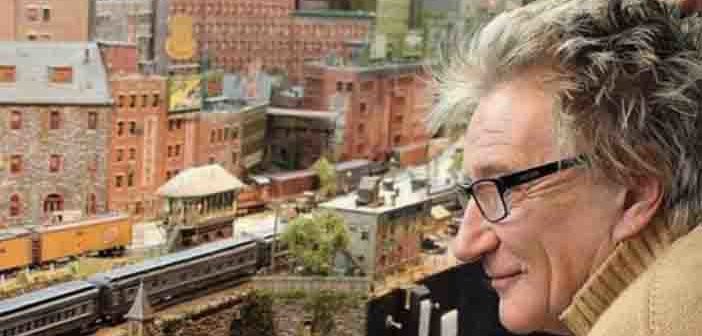Il 1969 è un anno piuttosto confuso per la storia dei Deep Purple, fatto di occasioni sprecate e di un album che non riesce a dare la svolta desiderata.
In pochi mesi del 1968 i Deep Purple hanno registrato due album, Shades Of e The Book of Taliesyn. In madrepatria la band è passata per lo più inosservata, ma in questa fase non sembra curarsene. La MK I infatti ha subito sfondato in America, la terra promessa di ogni band rock dell’epoca. Gli Stati Uniti offrono infatti un enorme bacino d’utenza per le vendite e lo sfondo ideale per interminabili tour milionari.
Con Hush, una cover di Joe South, i Deep Purple hanno ottenuto al primo colpo un singolo di successo straordinario. Il primo album, peculiare lavoro che mescola rock progressivo, psichedelia e i barocchismi dei Vanilla Fudge, ottiene buoni risultati. I Deep Purple, che in Gran Bretagna a stento riempiono piccoli club, in America firmano con la Tetragrammaton, etichetta rampante, e spuntano un tour come spalla dei Cream.
La band di Clapton e soci è in quel momento il complesso di maggiore successo del rock e i Deep Purple mettono su uno show all’altezza. Una leggenda metropolitana, addirittura, vuole che il management dei Cream li scarichi dopo poche date per non offuscare la classe di Clapton, Bruce e Baker.
Il 1969 inizia ed è già il momento di tornare in studio per registrare un nuovo album. Il ferro va battuto finché è caldo, certo, è il momento storico del rock impone una velocità micidiale, ben lontana dai tempi biblici con cui vengono incisi gli album oggi. Non tutto è così roseo, però. La Tetragrammaton, sebbene appena nata, si dibatte già tra i debiti. Alcune scelte poco azzeccate e investimenti andati male la pongono sull’orlo della bancarotta.
L’etichetta impone ai Deep Purple tempi e pressioni insopportabili. Tra tour e registrazioni il gruppo non ha tempo per pensare a nuove composizioni, ma un disco con tante cover come i primi è improponibile. In più, Emmaretta, il singolo che negli Usa dovrebbe replicare il trionfo di Hush, è un mezzo fiasco.
Tra febbraio e marzo i ragazzi registrano ai De Lane Lea Studios, con Derek Lawrence come produttore e Barry Ainsworth come tecnico del suono. Nella band ci sono già le prime tensioni; Jon Lord all’epoca pare il vero leader a livello compositivo e Blackmore ne è un po’ geloso. Un altro problema è prettamente economico: Hush, il loro successo milionario, ha come retro One More Rainy Days, pezzo non memorabile composto da Rod Evans e da Lord.
Le loro royalities – trascinate dal successo di Hush – sono così molto superiori a quelle del resto del band, che inizia a mugugnare. Blackmore e Lord, inoltre, vogliono scrollarsi di dosso l’etichetta di epigoni dei Vanilla Fudge e vorrebbero virare decisamente verso un rock barocco ma molto più duro. Oggi a pensarlo fa specie, visto che dei Vanilla Fudge in pochi si ricordano, ma allora la band americana era sulla cresta dell’onda.
L’indurimento della proposta, però, male si accorda con la voce di Rod Evans, validissima ma poco adatta e col basso di Nick Simper. Ian Paice, forse esagerando, ritiene la sua tecnica antiquata, come se fosse rimasta cristallizzata agli anni Cinquanta. Con questo stato d’animo contrastato, i Deep Purple entrano in studio con una manciata di composizioni originali. Ne verrà fuori un album eponimo, anche se alcuni lo chiamano Deep Purple III, pieno di intuizioni ma scarso di coerenza interna. E, soprattutto, un flop fenomenale nelle vendite, al punto che la Tetragrammaton fallisce. La distribuzione è a quel punto poco efficace e il disco arriva negli Usa appena al 162° posto in classifica.
Non solo, un tour coi Rolling Stones in America, che forse darebbe la definitiva spinta alla band, salta. Il motivo è un ripensamento sulle date della band di Jagger e Richards. Loro, già stelle mondiali, se lo possono permettere. I Deep Purple no.
Eppure, il terzo album della band britannica non suona affatto male, pur coi difetti di cui abbiamo detto. Proviamo ad ascoltarlo dopo più di cinquant’anni, ma prima un cenno alla copertina.
A conferma di una certa passione per i secoli passati, sulla cover campeggia un dipinto di Hieronymus Bosch: The Garden of Earthly Delights. Il pittore fiammingo è noto per le sue raffigurazioni da incubo che anticipano di secoli surrealismo e psichedelia. Nella bigotta America, il dipinto viene percepito come antireligioso e molti negozianti si rifiutano di esporlo. Per un errore grafico, che la band decide di assecondare, l’immagine è riprodotta in bianco e nero.

Deep Purple si apre con Chasing Shadow, un brano il cui testo è ispirato a un incubo ricorrente di Jon Lord. L’apertura e l’ossatura del pezzo sono basati su un’intuizione di Ian Paice, batterista mai troppo celebrato, che crea un tappeto di percussioni tribali da giungla africana. Chasing Shadow mette forse in mostra i limiti vocali del pur bravo Rod Evans, che non pare troppo a suo agio.
La lunga parte strumentale permette a Blackmore e a Lord di mettersi in luce coi loro tipici e lunghi assoli. Un brano che esalta le qualità dei singoli, ma che nel complesso non è un capolavoro.
Blind ha un bell’andamento sincopato e vede un certo riscatto di Evans, molto più in palla col ritmo più lento e i toni soul della canzone. Lord si cimenta al clavicembalo mentre Blackmore confeziona una parte di chitarra con un suono acido e abrasivo che risulta quasi straniante. Sicuramente un brano che riporta alle atmosfere dei primi album, molto interessante ma forse non del tutto centrato.

Il terzo capitolo di Deep Purple è anche l’unica cover della raccolta.
Lalena di Donovan nasce come ballata folk spiccatamente melodica; l’anno prima ha avuto buon successo nelle mani del menestrello britannico. La versione dei Deep Purple subisce il loro solito trattamento e si apre col tappeto d’organo e l’ispirata voce che declama con un ritmo lentissimo.
La parte centrale ospita una bella parte d’organo di Lord e una coda chitarristica insolitamente pacata e dolce. Il brano è riuscito, tuttavia la sua presenza piuttosto disorganica all’interno dell’album mette in luce una certa mancanza di direzione.
La prima facciata si chiude con due pezzi collegati. Il primo è il breve e bizzarro strumentale Fault Line, ispirato all’esperienza di un terremoto vissuta a Los Angeles. Senza soluzione di continuità arriva The Painter, una delle prime vere incursioni nel blues dei Deep Purple. Il pezzo si intitola inizialmente Hey Bop a Re Bop, poi i ragazzi decidono fortunatamente di ribattezzarla.
Il brano, sorta di funk blues, offre l’occasione a Blackmore e Lord di cimentarsi a modo loro con gli stilemi blues; un tentativo, probabilmente, di avvicinarsi sia al genere allora di grande successo in Gran Bretagna, sia a certe atmosfere simil Doors che in Usa spopolano. L’esperimento può dirsi riuscito, anche se The Painter – come la maggior parte di Deep Purple – sarà un po’ dimenticato in seguito.
Il lato B si apre con Why Didn’t Rosemary, altra cavalcata blues ispirata da un film in quel momento sulla bocca di tutti, Rosemary’s baby di Roman Polanski. Con un ritmo blues che incede quasi a ritmo marziale e una prestazione molto efficace di Evans, il brano riesce a incidere come si deve.
Dopo una breve parte alle tastiere di Lord è Blackmore a prendersi le luci con un lungo assolo, pertinente e molto ficcante. Davvero uno dei brani più riusciti dell’album e una delle migliori incursioni nell’hard blues dei Deep Purple.
The Bird Has Flown è forse il pezzo che più annuncia la futura grandezza dei Deep Purple, che arriverà di lì a breve. La voce di Rod Evans è in primo piano, più che nel futuro hard, ma la durezza del riff e dell’arrangiamento sono già da MK II. Al di là dell’importanza filologica, il brano è davvero bello.
La linea melodica è accattivante, così come il continuo alternarsi di accelerazioni e stop. La chitarra di Blackmore, trattata col wah-wah, puntella benissimo la parte ritmica prima di sciorinare un lungo assolo in perfetto stile Ritchie. L’ultima parte è tutta appannaggio dell’organo di Lord, che procede a lungo in solitaria prima di un finale esplosivo.
Deep Purple III si chiude con April, lunghissimo brano classicheggiante composto in prevalenza da Lord. April è forse la composizione più incline a un certo progressive epico e melodico dell’intera produzione. Non è una caso che all’epoca Jon Lord fosse al lavoro sulla stesura del concerto con l’orchestra che vedrà la luce poco dopo.
La parte centrale è tutta per l’orchestra, prima che nel finale rientri in modo prepotente la sezione ritmica. L’ideale sfondo per la parte vocale di Evans, che chiude in modo trionfale un brano che paga fin troppo l’inclusione in un album che incide poco nella discografia. Anche in April gli ingredienti del capolavoro ci sono tutti; eppure, la perfezione rimane lì a un passo, come se mancasse un pizzico di non si sa cosa alla ricetta.
Un cenno finale a Emmaretta. Il brano, singolo apripista del disco, come usava all’epoca rimane escluso dalla tracklist. Nelle successive ristampe il pezzo compare quasi sempre, tanto che lo possiamo a tutti gli effetti considerare parte del lavoro. Tuttavia, anche Emmaretta non è certo il capolavoro che i Deep Purple cercano ancora spasmodicamente.
Si tratta di una breve cavalcata hard rock aperta a qualche squarcio di melodia. I Deep Purple, insomma, sembrano nel loro terzo album in evoluzione, ma ancora senza una direzione precisa da seguire. Questo fa sì che, nonostante si possa considerare Deep Purple un passo avanti verso la piena maturità, il disco risulti tuttavia meno centrato dei primi due.
Poco male, di lì a poco, non senza strascichi polemici e giudiziari, avverrà il primo grande cambiamento nella formazione. Via Rod Evans e Nick Simper, dentro Ian Gillan e Roger Glover. Un avvicendamento condotto quasi in segreto, che certo poteva essere meglio gestito. Tant’è, non si può fare la frittata senza rompere le uova e, a cose fatte, la pietanza Deep Purple esce rinforzata. Pronta per entrare nel mito.