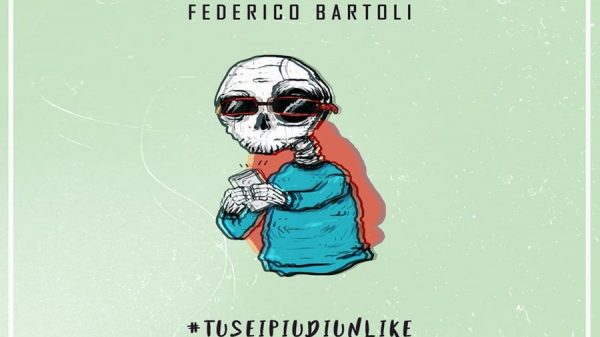Il 15 febbraio del 1974, quando “Burn” arriva finalmente nei negozi di dischi, c’è molta attesa tra gli appassionati del rock duro. Il lavoro è infatti il primo inciso dalla nuova formazione – denominata Mark III – e segna la rinascita di una band ormai data per morta.
Ma come si era arrivati in quella situazione? I Deep Purple non erano nuovi a cambi di formazione, tanto che la sigla Mk III fa capire subito come fossimo già al terzo rimpasto. Nata nel 1968 con Rod Evans alla voce e Nick Simper al basso, la Mk I era durata lo spazio di un album, “Shades of Deep Purple”, un buon lavoro ma ancora acerbo. L’innesto di Ian Gillan, frontman dalla voce potente e duttile e dalla presenza scenica indiscutibile, e del bassista Roger Glover, aveva portato i frutti sperati; dopo qualche tempo di assestamento erano arrivati i capolavori leggendari del gruppo: “In Rock”, “Fireball”, “Machine Head” e l’infuocato live “Made in Japan”. I riff al fulmicotone di Blackmore e il suo solismo estremamente personale, le urla di Gillan, le cavalcate tra rock e barocco di Jon Lord all’organo e una sezione ritmica (con Glover e Ian Paice) di potenza inaudita, avevano imposto i cinque ragazzi inglesi come uno dei vertici del triangolo hard rock composto con Led Zeppelin e Black Sabbath.
Ma una cosa quella formazione sapeva fare ancora meglio del rock: litigare.
Tra tour infiniti e tutti gli eccessi tipici della vita da rockstar, i contrasti erano all’ordine del giorno, specie tra Ritchie Blackmore e Ian Gillan, musicisti dal talento grande quanto lo smisurato ego. Alla fine del giugno del 1973, la notizia che è nell’aria da tempo finalmente arriva: Ian Gillan, seguito da Roger Glover, abbandona i Deep Purple.
A quel punto le possibilità che la band vada avanti sono davvero ridotte; ovviamente non andrà così. Ian Paice e Jon Lord assistono una sera a un concerto dei Trapeze, band di qualche successo nel calderone rock di inizio anni ’70, che sfoggia un cantante e bassista dal talento esuberante: Glenn Hughes.
Lord e Paice fanno due più due: la soluzione per andare avanti è a portata di mano e per sostituire i due dimissionari basta convincere Hughes che – ovviamente – accetta al volo.
Chi si mette di traverso è il management della band: i Deep Purple si sono imposti come quintetto e quintetto devono rimanere. Si continua allora a cercare e la vicenda qui acquista i contorni della leggenda. David Coverdale, un ragazzo di poco più di vent’anni dalla lunga chioma bionda e la voce cavernosa da bluesman, canta in modo amatoriale con alcune band e per mantenersi fa il commesso di negozio a Redcar; un giorno pubblica un annuncio su “Melody Maker” alla ricerca di una band vera e registra un demo in cui – palesemente alticcio – canta alcune cover. Incredibilmente viene scelto e, da un giorno all’altro, si ritrova da commesso a frontman di uno dei complessi rock più importanti del mondo.
Sulla carta la nuova formazione ha tutto per stupire e per continuare degnamente la storia dei Deep Purple, c’è solo da fare i conti col pubblico, affezionato alla formazione Mk II; il perfetto amalgama tra le voci di Coverdale e Hughes ha però del miracoloso e fa ben sperare. Tanto scura e perfetta per i registri più bassi quella del biondo David, tanto duttile e ottima nelle parti più alte quella di Glenn; le loro voci risultano perfettamente complementari, tanto da consentire ardite armonie vocali e una sterzata verso territori venati di funk e soul, come sarà sicuramente più evidente nel successivo “Stormbringer”. L’entusiasmo, poi, è quello tipico dei nuovi inizi.
Non tutto però funziona a dovere e “Burn”, va detto subito, non ha solo lati positivi; se, fino almeno a “Machine Head”, l’evoluzione dei Deep Purple era stata costante e quasi miracolosa, dando ogni volta alle stampe lavori sempre diversi tra loro e con una direzione musicale ben precisa, il processo con “Burn” viene un po’ meno.
Come rileva gran parte della critica, nonostante “Burn” sia un bel disco, con canzoni fortissime e con la novità del doppio cantante che viene ben sfruttata, i Deep Purple iniziano fatalmente a essere un po’ la rappresentazione di sé stessi, riproponendo una formula che da allora in poi – complice anche la fine del periodo d’oro del rock – sarà sempre la stessa, al netto della grande qualità.
Una nota a parte per la copertina, coi volti dei musicisti trasformati in candele in modo piuttosto discutibile; l’artwork – va detto – non è mai stato il pezzo forte del complesso.
Vediamo allora come suona questo “Burn”, analizzando le tracce.
Si parte con la titletrack, e siamo subito di fronte a uno dei momenti più esaltanti del disco.
La canzone attacca con un riff killer tipicamente in stile Blackmore, facendo subito intendere che – come nella famosa frase de “Il Gattopardo” – “Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi”. Il riff – e subito abbiamo una bella sorpresa – è incredibilmente modellato su “Fascinating Rhythm”, una canzone composta da George Gershwin nel 1924, mentre il testo è scritto da David Coverdale e disserta, a gentile richiesta di Blackmore, su streghe e demonologia. Il biondo cantante ha subito l’occasione di mostrare a tutti il suo talento, fino ad allora sconosciuto, mentre l’ugola altrettanto preziosa di Hughes viene subito sfruttata nel bridge e per le armonizzazioni. Per il resto il brano è una lunga cavalcata in perfetto stile Mk II, con duelli incandescenti tra la sei corde di Ritchie e l’organo di Lord, come sempre sospeso tra hard rock e musica classica. Possiamo solo immaginare l’entusiasmo dei fan all’epoca, nel ritrovare una band ancora più coesa nonostante il cambio di formazione, e un pezzo che nei live della Mk III sostituirà la mitica “Speed King”.
Si va avanti con “Might Just Take Your Life”, il brano che fu scelto come primo singolo dell’album. Anche qui siamo in presenza di un pezzo che si regge su un magistrale riff, guidato stavolta più dall’organo di Lord, ma con un ritmo decisamente più posato rispetto a “Burn”. Coverdale e Hughes si dividono equamente le parti vocali e armonizzano a dovere. Glenn ha comunque largamente modo di mettere in mostra le sue indubbie qualità canore. La canzone si chiude su un lungo assolo dell’organo.
“Lay Down, Stay Down” si apre con un piano da saloon che velocemente cede il passo a un bel riff quasi hendrixiano e alle voci che si alternano cantando in staccato; qui la canzone pare prestarsi più alla vocalità potente di Coverdale, anche se è forse il pezzo dove la mancanza di Ian Gillan si fa più pesante. Il tiro della batteria di Ian Paice è come sempre micidiale e l’assolo di Blackmore è tirato a una velocità supersonica; tuttavia l’ispirazione di Ritchie non sembra al top.
“Sail Away” è un brano non troppo celebrato del canzoniere dei nostri, tuttavia è – a giudizio di chi scrive – uno dei passaggi più ispirati del lavoro, e uno dei pochi in cui realmente si senta una direzione musicale che si sforza di essere nuova. Il riff della Stratocaster di Blackmore brilla per groove – sembra quasi un pezzo di Stevie Wonder – e il canto di Coverdale è quantomai azzeccato: anche qui il buon David pare più a suo agio di Hughes, specie nel bellissimo ritornello che si conclude con l’armonia delle due voci. Lord apre la sezione strumentale con una parte di tastiera lenta e suggestiva, mentre la coda spetta a Blackmore con una straniante parte di chitarra slide. Un brano ottimamente riuscito e finalmente qualcosa che suona diverso dal passato.
Anche “You Fool No One” ha una struttura molto particolare, con una base ancora ai limiti del funk e – curiosamente – la strofa cantata dalle due voci armonizzate che si separano per intonare il ritornello; di solito avviene il contrario, non che sia una regola scritta però. A metà pezzo parte il solito break strumentale con l’assolo di chitarra di Blackmore; ancora una volta un profluvio di note quasi hendrixiano, eppure il buon Ritchie sembra leggermente meno scintillante che in passato. Comunque un pezzo davanti al quale non si può fare altro che inchinarsi.
“What’s Going On Here” è un brano curioso, un bel boogie blues abbastanza dissonante nella produzione dei Deep Purple; la chitarra di Blackmore blueseggia pigramente e il piano di Lord evoca a più riprese la celebre “Roadhouse Blues” dei Doors; l’ispirazione che però sembra più venire fuori, assai bizzarramente, è quella dei primi ZZ Top, specialmente nell’assolo di stampo blues di Ritchie Blackmore, molto debitore a certi passaggi di Billy Gibbons. Una bella boccata d’aria fresca, anche se forse i fan del tipico suono Mk II si potrebbero trovare spiazzati.
La successiva “Mistreated” è un altro dei pezzi da novanta di “Burn”, uno slow blues travolgente e sofferto, dove David Coverdale finalmente si prende da solo la luce dei riflettori, dando fondo alle sue capacità. Il brano era stato scritto da Ritchie Blackmore un paio di anni prima e già preso in considerazione per “Machine Head”. La forte componente black dell’insieme era però stata reputata inadatta alle caratteristiche vocali di Gillan, e “Mistreated” era finita in un cassetto.
Il brano si apre col pesante incedere del riff di Blackmore che preannuncia l’urlo sofferto di Coverdale. Inizialmente David e Glenn Hughes incisero dei cori molto strutturati che dovevano fare da sottofondo alla parte solista della chitarra, tuttavia Blackmore – a cui sicuramente non dispiaceva fare e disfare – riteneva che il suono della sua Stratocaster non fosse così abbastanza in evidenza. Anni dopo David Coverdale, inizialmente deluso dal lavoro di sperimentazione andato sprecato, si disse comunque d’accordo con la versione ufficiale dell’arrangiamento. Il brano resta comunque un degno capolavoro nella discografia della band, un miracoloso equilibrio tra blues e melodia, tra carezza malinconica e rock duro. L’apporto di Lord, come in gran parte del lavoro, è minore che in passato.

“Burn” si chiude col brano più bizzarro e spiazzante, “A 200”, una sorta di bolero diviso tra la chitarra di Blackmore e i sintetizzatori di Jon Lord che in quel periodo il tastierista aveva iniziato a sperimentare. Il ritmo rimanda molto ad alcune parti strumentali del primo disco, quello “Shades Of” che ogni tanto tornava a fare capolino tra gli spartiti del complesso. La parte di sintetizzatore strizza l’occhio al prog ma anche alla celebre colonna sonora di “Arancia Meccanica” di Walter Carlos. La parte di chitarra è abbastanza ispirata, con Ritchie che gioca a ficcare il più alto numero possibile di note in ogni battuta. Il sintetizzatore di Lord riprende possesso e conduce in porto questo bizzarro esperimento, forse poco coerente col resto del disco ma che testimonia efficacemente gli ultimi sussulti di un’epoca densa di sperimentazioni.
“Burn” si chiude così, forse lasciando un po’ basiti gli ascoltatori, ma con la soddisfazione di un album che – pur non essendo certamente il capolavoro della band – prosegue degnamente la storia dei Deep Purple. La strada pare spianata per altri grandi successi, e invece il successivo “Stormbringer”, con la sua virata verso sonorità più calde e meno hard, scontenterà a tal punto Ritchie Blackmore che il chitarrista dirà basta e se ne andrà per formare i Rainbow.
Il futuro dei Deep Purple sarà all’insegna dei continui cambi di formazione – che dal 2002 si assesterà con la Mark VIII – e ci sarà spazio per tanti ritorni e altrettante partenze.