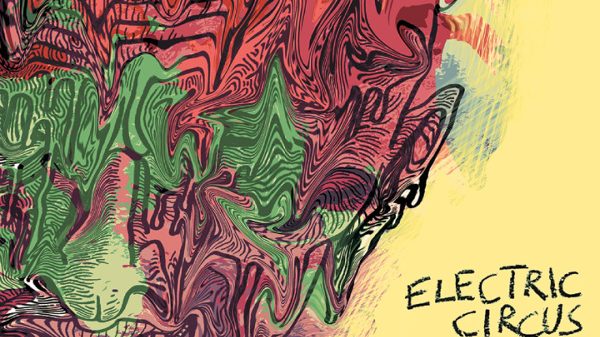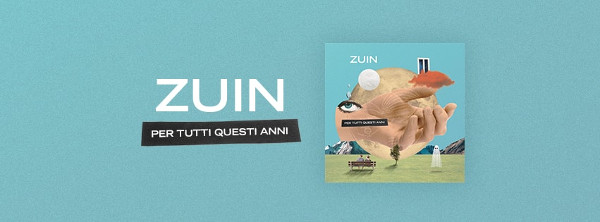Abbiamo analizzato tempo fa il disco “Concerto Grosso per i New Trolls”, ardito incontro tra musica barocca e rock progressivo, a opera del Maestro Luis Bacalov e della band genovese dei New Trolls. (leggi l’articolo)
L’ideale seguito di quell’opera di grande successo fu la collaborazione tra lo stesso Bacalov e gli Osanna, formazione napoletana in prima linea nel movimento prog.
L’album – intitolato “Preludio, Tema, Variazioni e Canzona” – faceva da colonna sonora al film noir “Milano Calibro 9”; la stessa cosa era successa per “Concerto Grosso”, nato come commento musicale de “La Vittima Designata”. Per capire la storia del disco occorre però un excursus in quegli anni di rivoluzione culturale e di grande successo del cinema di genere.
Il film è tratto dalla raccolta di racconti – omonima – del grande scrittore Giorgio Scerbanenco, primo a portare al successo il genere noir nella letteratura italiana e figura di primo piano nel tratteggiare alcuni temi ricorrenti degli anni ’70: il passaggio di Milano da grande città ancora legata alla tradizione a metropoli con criminalità organizzata paragonabile a quella delle capitali internazionali; personaggi cinici e disillusi; violenza al limite del pulp e dialoghi secchi e taglienti.
Non a caso Quentin Tarantino ha più volte indicato “Milano Calibro 9” come fonte di ispirazione e come miglior noir del cinema italiano. Il regista Fernando Di Leo si ispira in particolare a tre racconti della raccolta di Scerbanenco: “Stazione Centrale ammazzare subito” per la sequenza iniziale e “Vietato essere felici” e “La vendetta è il miglior perdono” per il personaggio di Ugo Piazza, magistralmente interpretato da Gastone Moschin. La pellicola, prima della “Trilogia del Milieu” del regista, è assurta nel tempo a vero e proprio cult, con le atmosfere da spaghetti western metropolitano, le grandi interpretazioni di Moschin, Mario Adorf e Philippe Leroy e la presenza di un’icona sexy come Barbara Bouchet.
Gli Osanna all’epoca – siamo nel 1972 – sono una delle più promettenti a rivoluzionarie realtà del progressive nostrano; il nucleo originale nasce come Volti di Pietra, per diventare poi Città Frontale. La formazione è costituita da Lino Vairetti, valente cantante, Danilo Rustici, chitarrista aggressivo e fratello di Corrado (prima nei Cervello e poi produttore di fama internazionale), Massimo Guarino alla batteria e Lello Brandi al basso. Decisivo è l’incontro con il talentuoso Elio D’Anna, flautista e sassofonista che proviene dagli Showmen di James Senese; i Città Frontale devono sostituire il partente Gianni Leone, destinato a un breve ma luminoso successo con Il Balletto di Bronzo, e D’Anna è l’uomo giusto.
Il gruppo si fa subito conoscere dal vivo e pubblica “L’Uomo”, primo album a nome Osanna, che riscuote ottimi consensi di critica e di pubblico.
Il 1972 è l’anno della collaborazione con Luis Bacalov. Rispetto al “Concerto Grosso” la colonna sonora riscuote meno successo di vendite e divide la critica: pur venendo riconosciuto il valore come commento musicale al film, sicuramente più dell’operazione coi New Trolls, “Preludio, Tema, Variazioni e Canzona” viene da subito ritenuto essenzialmente un lavoro di Bacalov, a cui gli Osanna prestano sì la propria maestria strumentale, ma da cui escono snaturati come band in senso stretto.
Col tempo – complice la rivalutazione del cinema di genere e il successo di Bacalov – anche le musiche del film e le parti degli Osanna vengono maggiormente apprezzate, tanto che oggi si può annoverare il disco come vero e proprio cult del genere.
Il disco, effettivamente, non può considerarsi a pieno titolo un album prog, essendo spiccate alcune caratteristiche da colonna sonora pura; siamo di fronte a dieci brani: tre sono composizioni di Luis Bacalov e sono “Preludio”, “Tema” e la conclusiva “Canzona (There Will Be Time)”. Gli altri sono costituiti da sette variazioni del tema principale, quasi esclusivamente strumentali, e composte direttamente dagli Osanna sul tema originale di Bacalov.
Mettiamo quindi sul piatto questo vinile e prepariamoci a un viaggio nelle atmosfere degli anni ’70, quelle cupe e violente di Scerbanenco e del genere “poliziottesco”.
La partenza, col celebre “Preludio”, è da brivido; il flauto di D’Anna svaria in libertà su un tappeto di sintetizzatore; all’improvviso irrompe un piano sincopato, alla maniera di certe colonne sonore di Morricone, per poi venire contrappuntato da una bellissima parte degli archi, sottolineata dal bordone chitarristico di Rustici – tutto sulle note più basse – e dai fiati. A un certo punto la tensione arriva al culmine e si risolve nel primo break rock, con l’ingresso della batteria; da qui in poi è un’emozionante altalena tra i contrappunti orchestrali e le parti di flauto e chitarra, prima della ripresa del tema principale.
L’armonia tra orchestra e band è perfetta, anche se per alcuni la grande creatività degli Osanna fu troppo sacrificata e ingabbiata dalla tela compositiva del maestro argentino.
La successiva “Tema” riprende la melodia della prima traccia in modo molto meno esplosivo. Il sintetizzatore ARP suonato da Vairetti traccia la melodia su un pianoforte piuttosto sommesso, con un violino che entra in modo quasi dissonante annunciando l’ingresso degli archi. Ancora il ricordo del Morricone western, negli accenti epici, fa capolino, prima che l’ingresso di basso, batteria e chitarra rendano lo struggente brano una cavalcata chitarristica psichedelica. Il valore di Danilo Rustici, musicista di grande valore, forse troppo poco ricordato, risalta pienamente, pur senza uscire troppo dal tema tracciato da Bacalov. Come in un percorso circolare, il brano riprende l’andamento iniziale e si conclude.
Con “Variazione I (To Plinius)” hanno inizio le variazioni composte e suonate dagli Osanna; “To Plinius” è dominata da una furente sezione ritmica che fa da sfondo a una chitarra che traccia un tema tipicamente da poliziesco dell’epoca, dalla tensione crescente e punteggiata da passaggi di sax quasi dissonanti. La seconda variazione, “My Mind Flies”, si apre in modo molto più placido e psichedelico, con flauto e chitarra che svariano liberamente. Una slide quasi floydiana si muove facendo da sfondo a una breve parte di vibrafono, suonato da Guarino, prima che la batteria introduca la parte più mossa del brano, guidata dal sintetizzatore. Finalmente arriva la prima parte vocale di Vairetti, accompagnata dalla chitarra acustica, un breve bozzetto che pare dovere qualcosa a certi intermezzi dei Pink Floyd più bucolici del periodo.
Dopo una furente parte di chitarra, la terza variazione (Shuum…) è aperta da un accenno di archi, per poi trasformarsi in una cavalcata flautistica di Elio D’Anna, palesemente ispirata ai Jethro Tull, con tanto di farfugliamenti vocali frammisti al flauto. La quarta variazione, intitolata “Tredicesimo Cortile”, inaugurata da una parte di chitarra violenta, propone scorci ambientali tipici da colonna sonora per poi riprendere il discorso elettrico, con la sei corde di Rustici pesantemente distorta e doppiata in sovraincisione per un effetto quasi straniante. La quinta variazione, “Dianalogo”, è una breve divagazione dell’orchestra, mentre la successiva “Variazione VI (Spunti dallo spartito n° 14723/AY del Prof. Imolo Meninge)” consiste in un bel duello tra il violino solista e gli strumenti rock, per trasformarsi poi in una furiosa divagazione chitarristica dagli accenti zeppelliniani.
“Variazione VII (Posizione raggiunta)” è un funk sostenuto con in evidenza il sassofono di D’Anna.
La conclusione è per la seconda traccia cantata, intitolata “Canzona (There Will Be Time)”; è una bella canzone romantica, composta da Bacalov e cantata da Vairetti con buona efficacia, anche nella pronuncia inglese; il pezzo decolla e propone un buon affiatamento ed equilibrio tra orchestra e band, tuttavia rimane sicuramente un episodio troppo avulso dal suono e dalle inclinazioni degli Osanna per dirsi totalmente riuscita. Troppo zucchero e troppa melodia, per una band che aveva fatto della sua creatività, dei suoni al limite dell’hard rock, un marchio di fabbrica.
Più o meno lo stesso può dirsi per il lavoro a tutto tondo, gradevole e giustamente assurto a icona di un periodo, ma troppo sbilanciato a favore delle composizioni di Luis Bacalov per lasciare il giusto spazio alle invenzioni degli Osanna.
La band napoletana si rifarà già nel 1973 con “Palepoli”, loro miglior lavoro e miracoloso crossover tra rock progressivo e suoni tradizionali napoletani.
Bacalov tenterà ancora la strada del connubio orchestra-band prog con Il Rovescio della Medaglia in “Contaminazione”, progetto sicuramente più strutturato ma che ha lasciato poche tracce in confronto ai precedenti.