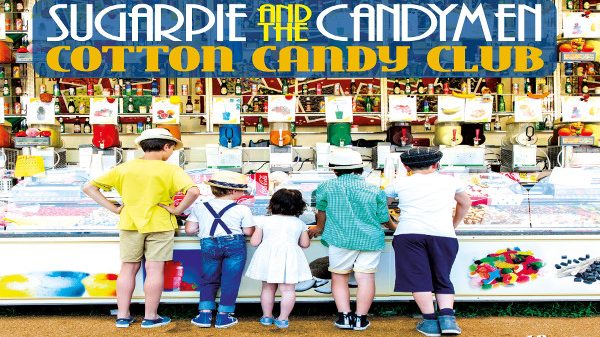Quando sta per finire il 1970, i Doors sembrano essere avviati sul viale di un tramonto nemmeno troppo tranquillo. Nel 1969 è uscito il deludente “The Soft Parade” e c’è stato il famoso incidente di Miami, quando Jim Morrison mostra i genitali durante un concerto.
Il fatto lo porterà alla condanna per reati contro la morale nel processo del 20 settembre del 1970. In mezzo la svogliata esibizione al Festival di Wight e una condizione psicofisica di Morrison sempre più preoccupante.
“Morrison Hotel” è l’unico segnale incoraggiante, un disco che ritorna alle radici blues della band e mette da parte gli arrangiamenti troppo sofisticati del lavoro precedente.
Le registrazioni dell’album successivo, “L.A. Woman”, non sono ancora terminate quando, il 12 dicembre, Jim Morrison collassa sul palco durante un concerto al Warehouse di New Orleans: è troppo, e i compagni di band decidono di non esibirsi più dal vivo.
Il nuovo disco, completato a gennaio, uscirà il 19 aprile del 1971, quando Morrison è già a Parigi. Deciso a vivere fino in fondo la vita del poeta bohemienne, Jim morirà poco dopo, a luglio. “L.A. Woman” si trova così l’infausta e imprevista responsabilità di rappresentare il testamento artistico di una band – che tenterà senza velleità di continuare senza il suo frontman – e soprattutto dell’uomo Jim Morrison.
E, in mezzo a questo vortice di situazioni al limite, il disco è un piccolo capolavoro, per alcuni il migliore della discografia della band losangelina.
Innanzitutto i musicisti decidono di allontanare lo storico produttore Paul A. Rothchild di cui non sono più soddisfatti; una diffusa diceria parla della contrarietà del tecnico verso “Riders on the Storm”, in realtà pare che Paul apprezzasse il brano, ma fosse contrario a quella che – a suo dire – era una deriva commerciale, rappresentata in particolare dal suono del brano “Love her madly”. Tuttavia, brani come questo, al limite del pop, non erano mancati nella produzione dei Doors, a partire dall’immortale “Light my fire” che ne aveva decretato il successo già agli inizi.
Fatto sta che al suo posto arriva Bruce Botnick, produttore più incline a un suono robusto, grezzo e senza fronzoli. Dopo alcune prove, i musicisti si riuniscono per registrare nel loro quartier generale, i Doors Workship di Los Angeles; Botnick utilizza un vecchio banco mixer a otto piste, mentre Jim Morrison registra alcune parti vocali nella stanza da bagno dello studio, nel tentativo di dare maggior profondità alla sua voce.
I testi delle canzoni, scritti perlopiù da Morrison, sono come sempre fondamentali per il lavoro, e passano dallo struggimento per Los Angeles, città amata da Jim ma che si appresta ad abbandonare, all’epica de “L’America”, originariamente scritta per “Zabriskie Point” di Michelangelo Antonioni e poi scartata dal bizzoso regista italiano.
La musica tende essenzialmente alle radici, tanto che “L.A. Woman” viene considerato il disco più blues del complesso, ma non mancano pezzi più sperimentali, al limite del recital e qualche passaggio quasi classicheggiante. Durante le registrazioni si aggiungono Marc Benno, chitarrista ritmico di Leon Russell e Jerry Scheff, bassista nella band di Elvis Priesley.
Mettiamo sul piatto “L.A. Woman” e sentiamo come suona quasi cinquant’anni dopo l’uscita.
L’album si apre con la spiazzante “The Changeling”, un funky quasi alla James Brown dove il ritmo ballabile si abbina a un testo quasi disperato sul protagonista che, come suggerisce il titolo, si scopre scambiato nella culla e vive una vita ai margini, bipolarmente sospesa tra libertà e mancanza d’identità.
I versi in cui Jim – col suo vocione – dichiara di voler abbandonare la città, saranno un po’ il fil rouge dell’intero disco, una sorta di addio all’amata Los Angeles e forse al mondo terreno. L’organo di Manzarek ha quasi la funzione che avrebbero avuto i fiati in un pezzo del buon vecchio James Brown, mentre la chitarra di Krieger monopolizza le parti soliste, prima con un wah-wah più claptoniano che hendrixiano e poi con una parte più smaccatamente psichedelica.
“The Changeling”, nelle intenzioni della band, avrebbe dovuto essere il singolo di lancio, ma la produzione li convinse a scegliere la successiva, famigerata “Love her madly”. Il brano, scritto da Krieger pare dopo una litigata con la moglie, si avvale di una melodia piuttosto accattivante e ottiene discreto successo, risultando però un po’ leggero rispetto all’atmosfera del resto dell’album. Musicalmente siamo dalle parti del beat, tra Yardbirds e qualche fraseggio blues, compreso un assolo di Krieger con un suono della chitarra talmente pulito e privo di saturazione da sembrare quasi jazz. Certo, mentre in Europa impazzava il nascente rock progressivo, questo singolo doveva apparire terribilmente datato, sicuramente più di quanto non appaia oggi.
Con “Been Down so Long” torniamo in piena atmosfera blues, con un pezzo originale ma completamente compreso nei confini – anche strutturali – della musica del Diavolo. Il titolo è preso, secondo alcuni, dal romanzo di Richard Fariña Been “Down So Long It Looks Like Up to Me” del 1966, ma è vero che il verso era un tipico modo di dire dei bluesman fin da un pezzo di Furry Lewis del 1928. La struttura musicale è totalmente blues, col vocione di Morrison che ripete la strofa due volte per poi rispondere nella terza; Manzarek suona eccezionalmente la chitarra, mentre Krieger si abbandona a svolazzi selvaggi con la slide, sotto la guida ritmica quasi marziale del basso di Scheff. Un blues degno in tutto e per tutto della grande tradizione nera del genere.
“Car Hiss by my Window” prosegue il discorso blues: siamo di nuovo in un canonico pezzo a dodici battute, ma l’atmosfera è quella rilassata dello spleen post sessuale, magari aiutata da qualche sostanza psicotropa su cui è meglio non indagare. Il testo si a mano a mano più oscuro, mentre la chitarra di Krieger e la batteria spazzolata, ai limiti del jazz, di Densmore tracciano le coordinate del brano. Un primo assolo del chitarrista, in stile Clapton rilassato, precede quello finale, sorprendente: a tutta prima pare un wah-wah suonato con la slide, un po’ alla J.J. Cale. Ci vuole qualche secondo per capire che è la voce di Jim Morrison che imita alla perfezione il suono piangente della chitarra effettata; uno scherzo, un divertissement che però la dice lunga sull’abilità tecnica di Jim.
Il brano che chiude il lato A è anche quello che dà il titolo alla raccolta e segna l’addio di Morrison alla sua amata città. Si tratta di una lunga cavalcata boogie blues, le cui parti di chitarra di Krieger, molto in evidenza, si collocano in pieno blues psichedelico, quasi a evocare i favolosi Quicksilver Messenger Service di John Cipollina. C’è spazio per tutto, però, nei quasi otto minuti del pezzo, dal piano honky tonk di Manzarek a una parte molto rallentata che prelude alla ripresa del tema iniziale. Otto minuti che ancora oggi riempiono di rimpianto, pensando a quanti altri capolavori la band ci avrebbe potuto regalare.
Il lato B è quello più sperimentale dell’opera e si apre con “L’America”, aperta dalle note secche della chitarra di Robby Krieger che tracciano un bordone inquietante, prima dell’ingresso di Densmore e della sua batteria marziale. Morrison snocciola il testo col suo tipico fare sciamanico, quasi recitando, prima di un breve ritornello che si apre ancora a temo blues. Sostanzialmente siamo in piena psichedelia, un movimento che in quel 1971 era stato ampiamente superato – e infatti la stesura del brano, destinato ad Antonioni era ben precedente – dando una connotazione datata al brano.
Si prosegue con “Hyacinth House”, ballata che sembra incedere in modo quasi leggero, se non fosse per la voce tombale che, in modo stridente, declama versi di disperata solitudine. Non è difficile, a posteriori, rintracciare quella disperazione esistenziale che in pochi mesi porterà a un tragico epilogo la vita di Jim. Ray Manzarek si concede una citazione colta, suonando all’organo un tributo alla famosa “Polacca in La bemolle maggiore op. 53” del compositore polacco Fryderyk Chopin.
“Crawling King Snake” è l’unica cover del disco, da John Lee Hooker, che a sua volta l’aveva ripresa da un vecchio standard tradizionale, ma si inserisce talmente bene nel tessuto musicale dell’opera da sembrare farina del sacco di Jim e soci. Ovviamente siamo di nuovo nel campo del blues più scuro e canonico, con Morrison che si trova completamente a suo agio nei panni del crooner blues e Krieger che snocciola un assolo perfettamente pertinente allo stile. Bellissima e discreta la parte d’organo di Manzarek che, con poche note, cala il brano nella tipica atmosfera liquida e sognante dei Doors.
“The WASP (Texas Radio and the Big Beat)” è forse l’esperimento più ardito della raccolta: su una base di nuovo blues, Morrison recita versi stranianti e psichedelici, metafore assurde che forse vogliono essere una condanna di una certa società americana. La sezione centrale ospita un lungo assolo di chitarra, mentre il finale è appannaggio dell’organo di Manzarek, prima della chiusura di Morrison, quasi da musical.
L’album – e la carriera di Jim Morrison – si sta per chiudere, ma c’è lo spazio per un capolavoro, forse il più bel brano dell’intera discografia dei Doors: “Riders on the Storm”. Il brano, ispirato a Morrison dal classico country “Ghost Riders in the Sky”, si apre con gli effetti sonori di un temporale: tuoni e pioggia scrosciante sottolineati dalle note dell’organo di Manzarek, liquido quanto l’acqua del rovescio.
La voce di Morrison – qui davvero perfetta – ci precipita nell’oscuro testo che fa riferimento a un autostoppista killer, pare modellato sulla figura di Billy Cook, serial killer che nel 1950 uccise sei persone, tra cui l’intera famiglia Mosser, aggredendone anche altre, facendosi dare passaggi in giro per gli Stati Uniti prima di essere catturato e giustiziato nel 1952.
Tutta la parte centrale è opera di Manzarek, che suona qui le note più iconiche di tutta la carriera, evocando il temporale e alternando parti molto più rilassate, tanto che secondo le dicerie il produttore Rotschild avrebbe definito il pezzo “musica da cocktail”, a testimonianza di come anche il professionista più serio possa prendere una solenne cantonata. “Riders on the Storm” è il brano perfetto dei Doors, quello che da solo vale una carriera: il fatto che i ragazzi di Los Angeles l’abbiano messo a segno come uscita di scena amplifica il rimpianto a dismisura.
Ma tant’è, Jim volerà a Parigi per chiudere la sua esistenza come lo status di leggenda vivente forse esigeva, ad appena ventisette anni, lasciandosi dietro un ostinato culto alimentato ad arte da magliette e poster.
E le vestigia di una grande band, troppo dipendente dal suo carisma per tentare di proseguire da sola.
Andrea La Rovere – Onda Musicale