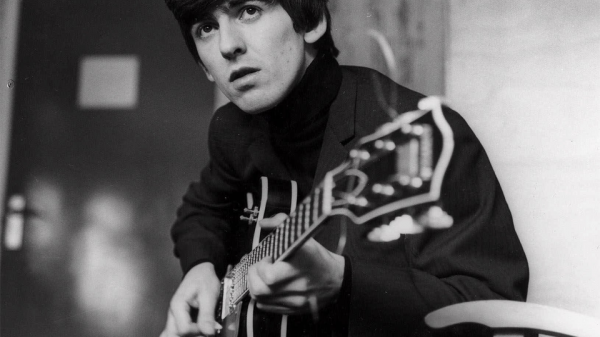San Francisco alla fine degli anni Sessanta è la patria della Summer of Love e del rock psichedelico, da quello militante e schierato dei Jefferson Airplane a quello degli acid test dei Grateful Dead. C’è però una terza via, meno cerebrale e più rumorosa, quella dei Blue Cheer.
L’estate dell’amore – quella del 1967 – è rimasta nell’immaginario collettivo per i figli dei fiori, gli hippies e il pacifismo, la nascita dei grandi festival e la musica rock dilatata in lungo e in largo grazie all’apporto di sostanze psicotrope di lì a poco vietate come l’LSD.
Accanto a gruppi che inseguono l’intento prettamente psichedelico di allargare le coscienze attraverso la musica, gli Aiplane e i Grateful Dead, ma anche i Quicksilver Messenger Service e i Love, si agitano però anche altre istanze e stati d’animo.
Se sulla costa est degli Stati Uniti i Velvet Underground e gli Stooges di Iggy Pop anticipano il futuro avvento del punk con un rock rumoroso, iconoclasta e nichilista, e a Detroit gli MC5 predicano anarchia e azione attraverso una musica potente e asciutta; nella stessa San Francisco, tre ragazzi con qualche esperienza alle spalle e tanta voglia di far casino, incidono un album che negli anni sarebbe assurto a cult e indicato – a volte senza grande fondamento – come pietra angolare di una serie di generi con cui in realtà ha poco a che fare: sono i Blue Cheer.
E proprio il nome scelto da Dickie Peterson si rifà – in modo quasi programmatico – alle droghe sintetiche; “Blue Cheer” era infatti un famoso ammorbidente e Owsley Stanley, ingegnere del suono e chimico clandestino legato a doppio filo coi Grateful Dead, aveva deciso di chiamare così una varietà di LSD da lui sintetizzata.
Peterson è bassista e cantante e ha militato negli Andrew Staples & The Oxford Circle, una band dalla poca gloria; nel 1967 decide di fare le cose più in grande, raccogliendo attorno a sé Leigh Stephens ed Eric Albronda. Il primo è un chitarrista che si ispira a Jimi Hendrix, non tanto nella tecnica – non proprio smagliante – quanto nell’uso compulsivo di distorsore e feedback; Albronda è un batterista che presto si tirerà indietro, lasciando il posto a Paul Whaley, già compagno di Peterson nella sua prima band. Sotto la direzione di Allen “Gut” Terk, membro dei discussi Hell’s Angels, si aggiungono inizialmente altri tre membri: Jerre, fratello di Peterson (chitarra), Vale Hamanaka (tastiere) e Jere Whiting (voce, armonica).
L’assetto a sei dura ben poco e presto il gruppo si assesta a “power trio” con uno stile ricalcato su Cream e Jimi Hendrix Experience, complessi con cui i tre volenterosi ragazzi non possono certo rivaleggiare come tecnica e livello compositivo; messa da parte la qualità, decidono di competere su un terreno meramente quantitativo, alzando i volumi degli strumenti e portando la distorsione dei suoni là dove mai nessuno si era spinto.
Negli anni molti hanno fatto risalire a “Vincebus Eruptum”, loro esordio e capolavoro, inciso alla fine del 1967 e uscito il 16 gennaio del ’68, la nascita dell’hard rock o – addirittura – dell’heavy metal. La seconda ipotesi è forse meno peregrina, per quanto i discendenti più diretti dei tre Blue Cheer sono forse lo stoner e il grunge, soprattutto come approccio, ancor prima che per i suoni. In realtà la band poggia su basi solidamente psichedeliche ed è dedita a una musica che attinge pesantemente al blues – dilatato e distorto a dismisura – e può essere accomunata a hard rock e metal non tanto per la struttura compositiva, quanto per il livello rumoristico che raggiunge quasi il parossismo.
Se consideriamo pietre angolari dell’hard i di poco successivi lavori di Led Zeppelin, Deep Purple e Black Sabbath, ma anche di Uriah Heep e Atomic Rooster, la differenza in quanto a complessità strutturale e a capacità tecniche, salta all’occhio; ma sono anche fattori meramente strumentali a sancire la paternità dei generi: le urla in falsetto di Plant e Gillan hanno forgiato generazioni di shouter metal e così i fraseggi chitarristici di Blackmore, slegati dal blues, gli agganci folk di Page e i riff granitici di Iommi, tutte innovazioni che non si ritrovano nel disco dei Blue Cheer.
D’altra parte, è pur vero che il debutto dei musicisti di San Francisco avrebbe fatto breccia nel cuore di molti critici e musicisti coevi: Jim Morrison li definisce “la band più potente mai sentita” ed Eric Clapton – anni dopo – attribuisce loro la paternità del genere heavy metal. Per Tim Hills i Blue Cheer sono l’epitome della psichedelia di San Francisco. La leggenda narra che anche i Beatles in pezzi come “Yer Blues” o “Helter Skelter” sfruttassero in parte quella rivoluzione rumorosa partita da San Francisco.
Dopo cotanto preambolo, però, è ora di togliere il disco dalla sua custodia dalla grafica che è la quintessenza della psichedelia, e ascoltare come “Vincebum Eruptum” ha affrontato i marosi del tempo.
“Vincebum Eruptum”
Il lavoro si apre col loro successo commerciale più grande, “Summertime Blues”.
Il pezzo è una versione incendiaria del cavallo di battaglia di Eddie Cochran, alfiere del rock’n’roll ai tempi di Elvis con la sua chitarra arancione e prematuramente scomparso per un incidente stradale. Allora non era certo pratica rivoluzionaria quella di dare una nuova vernice a classici del genere, dilatando i tempi e alzando la manopola del volume, “Who Do You Love” di Bo Diddley nell’interminabile versione dei Quicksilver Messenger Service di John Cipollina ne è un esempio formidabile. Quello che cambia nei Blue Cheer è l’approccio: se la band di John si perdeva in lunghe cavalcate dove la chitarra vagava tra rock, blues, jazz e atmosfere orientaleggianti, all’insegna di un deliquio da post LSD, qui Peterson e soci mirano dritti al cuore della questione, regolando gli amplificatori a un volume tale che pare quasi debbano friggere da un momento all’altro.
Il basso di Dickie sembra quasi il rombo di un tuono, la batteria pesta senza badare troppo a raffinatezze e la chitarra di Stephens si inserisce dopo le strofe un po’ come faceva Clapton in “Outside Woman Blues” dei Cream, vera ispirazione di questo pezzo. Il suono di Leigh è rotondo e saturo, con l’overdrive al massimo delle possibilità di allora, e se la tecnica non è proprio il massimo della pulizia, pazienza.
L’incedere ritmico dell’accoppiata basso-batteria più tonitruante mai vista ha qualcosa di tribale, quasi come se fosse un’oscura danza rituale di qualche tribù nativa. Tra rave up strumentali alla Yardbirds e cambi di ritmo, Stephens si ritaglia un assolo selvaggio e dirompente. Se il pezzo originale di Cochran era alla sua epoca un inno della ribellione adolescenziale, a confronto con la sgarbata versione Blue Cheer pare quasi un coro di voci bianche di una chiesa protestante inglese.
La successiva “Rock Me Baby” fa col blues quello che il pezzo precedente ha fatto col rock’n’roll. Il brano, tratto dal canzoniere di B.B. King, si regge sul basso ipertrofico di Peterson, che canta con ugola di carta vetrata, mentre Stephens è – almeno all’inizio – più tranquillo nel macinare il riff tipicamente blues del brano. Gli schiamazzi di Dickie lanciano l’assolo di chitarra del suo compare, una cavalcata bizzosa, degna di un Jimi Hendrix che si è svegliato mettendo giù il piede sbagliato, dove però il buon Leigh riesce un po’ meglio a tenere a bada i suoi demoni, fornendo una prestazione più misurata, per il senso che può avere questo termine collegato al suo stile. Dopo una ripresa del tema di un Peterson sempre più sguaiato – e a suo modo efficacissimo – il finale è di nuovo all’insegna del rumore più bieco.
E anche il blues è sistemato.
La successiva “Doctor Please” è la prima composizione originale, firmata da Peterson, una cavalcata di quasi nove minuti. Il canto di Dickie, selvaggio e dirompente, si staglia su una base ritmica sincopata, segnata dai fraseggi isterici della chitarra di Stephens, che nella parte solista cita a piene mani i suoi idoli psichedelici Eric Clapton – che allora era musicista granitico – e Jimi Hendrix, prima di abbandonarsi a una improvvisazione che pare quasi una colata lavica di blues, all’insegna della frenesia più totale.
Mentre la ritmica pompa a una velocità degna dei Motorhead di oltre dieci anni dopo, la schizofrenica chitarra di Stephens zampetta tra una scala e l’altra senza badare troppo alle finezze, prima di riaprire il tema iniziale e chiudere con un altro assolo ancora più dissonante, col suono talmente saturo da non essere quasi retto dall’amplificatore.
La seconda facciata si apre con “Out Of Focus”, ennesimo pezzo inneggiante agli stati alterati indotti dalle droghe, con un tono leggermente più amichevole rispetto al selvaggio lato A. L’andamento ricorda quasi certe cose di Janis Joplin, la ritmica ha un certo groove e c’è perfino un ritornello, o qualcosa di simile. La chitarra è però sempre sopra le righe e, anzi, il breve assolo in cui Stephens si doppia da solo con due incisioni sovrapposte è quanto di più delirante si possa pretendere da un uomo che imbraccia una chitarra elettrica.
La seguente “Parchment Farm” è una cover di Mose Allison, a cui Dio sa perché i tre storpiano leggermente il titolo (“Parchman Farm”). Il brano è già stato omaggiato da Johnny Winter e John Mayall, di sicuro con più discrezione, ma anche la versione dei Blue Cheer conserva una certa attinenza con l’originale, se non fosse per la sezione centrale, sempre appannaggio dell’urticante elettrica di Stephens, con tanto di semi-citazione del riff di “Sunshine of Your Love” e di una lunga cavalcata che parte quasi in sordina ma finisce per degenerare nei suoni lancinanti tanto cari al chitarrista.
Si chiude con “Second Time Around”, altro originale di Peterson che non sposta le coordinate di quanto sentito finora. Il cuore è ancora nel delirio centrale di Stephens, che propone di nuovo un doppio assolo sovrapposto, a tratti dissonante, a momenti più ligio al verbo psichedelico, ma sempre distorto oltre ogni immaginazione per il periodo e – in fin dei conti – anche per oggi. Ad appesantire una situazione che inizia a farsi a questo punto un po’ estenuante, arriva anche un lungo assolo di batteria di Whaley, prima che il brano si chiuda con una coda infuocata e al limite del rumoristico bello e buono.
Si arriva alla fine di “Vincebus Ereptum” abbastanza sfiniti, nonostante la breve durata del disco: possiamo solo immaginare come l’album potesse suonare alle orecchie dell’epoca, abituate a ritenere il suono di Eric Clapton tra i più duri mai sentiti. I Blue Cheer sono una band di selvaggi e rozzi primitivi, al confronto di quello che si sentiva allora, eppure con alcune intuizioni riescono a mettere a segno un disco epocale, se non per la qualità tecnica, sicuramente per l’importanza e l’influenza che il loro suono avrà in futuro.
Insomma, pur senza anticipare le trame complesse del metal e l’approccio hard nello svincolarsi dalle radici blues, i Blue Cheer riescono a lasciare la loro impronta nella nascita dei due generi, pur attingendo alle stesse fonti dei compari psichedelici della San Francisco del 1967.
Un’impronta selvaggia e rumorosa, questo è certo.