I Deep Purple hanno scritto alcune delle pagine più importanti della storia del rock, specie nei primi anni Settanta. Una storia che sembrava finita nel 1976, con la morte del chitarrista Tommy Bolin; e invece, quasi dieci anni dopo, la vicenda dei Deep Purple riprendeva con Perfect Strangers.
Riannodiamo i fili della storia dei Deep Purple fino a Perfect Strangers.
Nati alla fine degli anni Sessanta attorno al chitarrista Ritchie Blackmore e al tastierista Jon Lord, i Deep Purple si mostrano inclini ai cambiamenti da subito. Le formazioni sono contraddistinte dalla sigla Mk, come era d’abitudine coi modelli d’auto.
La MkI vede Rod Evans alla voce, Nick Simper al basso e Ian Paice alla batteria, oltre ai due fondatori. Shades of Deep Purple è un discreto successo negli Usa e propone un sound blandamente sospeso tra psichedelia e pop barocco; gli album successivi non riescono a sfondare e Blackmore preme per cambiare.
La sua idea è quella di portare i suono verso un robusto hard rock, con venature prog e qualche passaggio classico; alla voce arriva Ian Gillan e al basso Roger Glover. Ian è il frontman che manca alla band e sfoggia una voce prodromica di tanti cantanti metal che verranno, tutta feeling e vocalizzi.
In Rock, Machine Head e Made in Japan sono pietre miliari dell’hard rock e non solo. La vita in tour, il carattere bizzoso di Blackmore e gli eccessi da rockstar portano però la formazione MkII alla crisi di nervi. Il complesso è troppo piccolo per Gillan e Blackmore e le loro bizze da primedonne; il carismatico Ian abbandona e si trascina dietro Glover.
Quella che sembrava la fine del gruppo segna invece la nascita della MkIII. L’arrivo di David Coverdale e Glenn Hughes sposta però il baricentro verso lidi funk che poco hanno a che vedere con la visione di Ritchie Blackmore. La nuova diaspora vede il chitarrista abbandonare per formare i Rainbow. Al suo posto arriva Tommy Bolin, con cui i Deep Purple MkIV licenziano il buon Come Taste the Band.
Appena un anno dopo, però, Tommy muore di overdose e stavolta la parola fine viene scritta sulla vicenda dei Deep Purple. Gli anni successivi vedono i vari componenti cercare il successo per vie svariate. Ritchie Blackmore può finalmente fare il despota coi suoi Rainbow, tuttavia dopo un paio di ottimi dischi il sound si annacqua; la band si sposta verso un sound AOR che non accontenta nessuno. Glover, dal canto suo, collabora sia con Gillan che con Coverdale, per poi finire a suonare proprio coi Rainbow.
Jon Lord si tiene impegnato in mille progetti e suona anche coi Whitesnake, la nuova band di Coverdale. Ian Paice fa parte a sua volta dei Whitesnake e poi della band di Gary Moore. Gillan cerca prima invano e poi con qualche soddisfazione il successo solista, per poi finire con poca convinzione nei Black Sabbath, rivali storici.
Per anni i vari componenti giurano e spergiurano che i Deep Purple non si riuniranno mai: le cose andranno diversamente. Le voci di una reunion si fanno via via più insistenti; a turno pare sempre mancare il proverbiale trenta per fare trentuno. Il più deciso pare Roger Glover.
“Beh, per sei anni circa sono stato fortemente contro. Sono andato agli incontri che abbiamo tenuto inizialmente, con una mentalità del 50% in favore e 50% contrario. Quando ci siamo seduti tutti al tavolo, tutti e cinque, – questo può sembrare stupido – ma ho cominciato subito a sentire un sentimento magico, una scintilla di eccitazione nell’aria. Così ho cominciato ad andare da quel 50/50 ad un 70/30. E poi, subito dopo aver suonato un po’ di tempo insieme, sono diventato del 100% a favore. Sul serio, è stato così bello.”
Roger Glover
Così dichiara Roger Glover. In realtà il compenso messo sul tavolo dalla Polydor per la reunion è talmente faraonico da togliere ogni residuo dubbio; si parla di milioni di dollari. Il mondo del rock, tuttavia, nel 1984 è molto diverso da quello che i Deep Purple avevano lasciato ancora sulla cresta dell’onda. Tute e acconciature vaporose hanno preso il posto di jeans, stivali e chiome ruggenti; c’è stata l’ascesa e subitanea fine del punk e l’esplosione del rap.
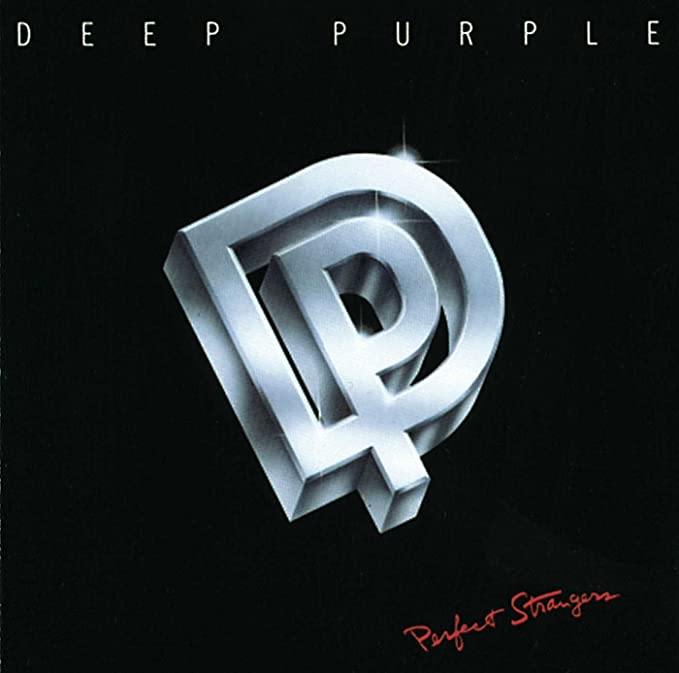
Il posto dei Deep Purple può situarsi tra l’ondata heavy metal, di cui loro stessi sono stati il modello, e l’AOR. L’Adult Oriented Rock spopola in America con band come Toto e Boston; si tratta di una sorta di hard rock melodico e patinato che tanto piace al pubblico americano ma che dista parecchio dal sound duro e grezzo dei Deep Purple dei bei tempi.
Per la produzione di Perfect Strangers i nostri giocano in casa: se ne occupa Roger Glover.
L’attacco di Knockin’ at your Door non chiarisce perfettamente da che parte hanno deciso di giocare i Deep Purple. Il testo è nella loro tradizione, uno sfoggio di machismo pienamente in linea con l’immagine di rockstar eccessive, la musica è pericolosamente in bilico tra vecchie atmosfere e patina anni Ottanta.
Il riff di Blackmore è piuttosto blando, dalle parti dei Toto, ma quando entra la voce di Gillan la magia pare riaccendersi; Blackmore si prende una ricca sezione centrale sfoderando un bell’assolo, più vicino al metal che agli anni ’70. Il drumming di Ian Paice è potente ma piuttosto basico rispetto al batterista inarrivabile di dieci anni prima.
Il giudizio rimane sospeso, e intanto parte il secondo pezzo: Under the Gun.
Il brano è leggermente più veloce, nel ritornello si sfiora il puro rock’n’roll. Il testo gira intorno all’antimilitarismo in modo non troppo ispirato. Blackmore si prende ancora le luci per l’assolo di chitarra; tra effetti, leva del vibrato tirata allo spasimo e qualche passaggio classico, Ritchie se la cava con gran mestiere e velocità. La magia dei bei tempi è però lontana; l’obiettivo di far suonare Perfect Strangers come il Machine Head degli anni ’80 per ora pare irraggiungibile.
Un bel punto però i Deep Purple lo mettono a segno con Nobody’s Home; Gillan è più istrionico che mai, il riff è di quelli tosti e l’assolo di Blackmore è questa volta messo in secondo piano da quello di Jon Lord. Sì, perché finalmente torna a prendersi la scena il magico Hammond di Lord, per la verità un po’ disperso già dai tempi della MkIII. Non è certo la parte d’organo più ispirata di Jon, ma è comunque un bel sentire.
Il buon momento continua con Mean Streak, brano sostenuto che pare uscire dritto dai tempi d’oro della band. Ian Gillan è più ispirato che mai, i riff sono potenti e insinuanti e la simbiosi tra Lord e Blackmore sembra quella di una volta. L’assolo di Ritchie è di quelli da ascoltare e riascoltare, Lord è invece un po’ più defilato. Un ottimo pezzo.
A seguire Perfect Strangers, la title track. Si tratta probabilmente del brano più pretenzioso della raccolta, nelle intenzioni una sorta di Kashmir dei Deep Purple. L’incedere è maestosamente marziale, gli intarsi di chitarra e organo suggeriscono atmosfere orientali.
Tuttavia la sezione centrale stenta a decollare e il pezzo va avanti senza mantenere completamente le promesse.
A Gypsy’s Kiss è di nuovo un pezzo del più genuino hard rock, dall’andatura sostenutissima. Il momento migliore è nella sezione centrale, dove l’organo di Lord e la chitarra di Blackmore tornano a duellare come ai vecchi tempi. Siamo davvero di fronte a un brano che non sfigurerebbe in nessuno degli album del periodo d’oro della MkII.
Wasted Sunsets è l’immancabile ballatona di ogni album hard rock, il momento degli accendini, almeno all’epoca. Al di là dell’usanza – per chi scrive – discutibile di dover per forza inserire un brano lento e d’atmosfera, Wasted Sunsets è un riuscito insieme di cliché. La chitarra di Blackmore, ispirata e melodica, pare uscita da un album di Gary Moore, mentre la prestazione di Gillan è strappalacrime al punto giusto.
La melodia non è quanto di più originale si sia sentito nel genere, va detto, ma il risultato è comunque buono.
Hungry Daze è di nuovo un bel brano sostenuto che narra le storie del tempo che fu; riuscito sì, ma a questo punto si comincia a fare un po’ di confusione con una serie di canzoni del disco, forse troppo simili tra loro. Il vinile si chiude qui, e forse è la scelta più saggia. Per chi all’epoca avesse invece acquistato il CD o la cassetta, c’è un ulteriore brano.
Not Responsible è un brano più cupo dei precedenti, non pienamente riuscito ma con un bell’assolo di chitarra ai limiti del rock-blues. Tutto sommato Perfect Strangers suona meglio senza quest’ultimo episodio.
L’album ottiene un buon successo, pur senza fare sfracelli; il materiale inedito è però più la scusa per portare i Deep Purple in giro per il mondo, in un tour – quello sì – milionario e che li consegna alle folle in gran forma. Certo, il video di Perfect Strangers, tra supercar e ville di lusso, chiome non più così fluenti e fisici appesantiti, è l’impietosa istantanea del tempo che passa; e forse anche di un gruppo di musicisti superati dalle nuove mode.
La rinnovata alchimia funziona comunque per poco; presto i caratteri tornano fuori e le liti tra Gillan e Blackmore riprendono – almeno quelle – come se il tempo non fosse passato. Ricomincia il balletto di formazioni, che va avanti ancora oggi con tutti i musicisti in piena attività, eccetto il compianto Jon Lord.
Perfect Strangers è insomma la fotografia di una band ancora capace di grandi brani e virtuosismi; un grande album di rock che paga pegno agli anni ’70 ma prova a stare al passo degli ’80, senza riuscirci sempre. La prova provata che spirito del tempo e talento debbano andare a braccetto, sempre. Un album a cui manca il colpo del K.O. ma che – dopo – 37 anni, si fa ascoltare con piacere.
I tempi di In Rock e Machine Head, però, rimangono lontani e irraggiungibili.








